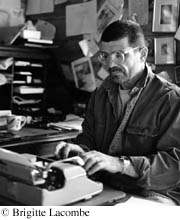|
Liletta
Fornasari, Pietro Benvenuti
Firenze:
Edifir, 2004, 407 pagine, 323 illustrazioni. ISBN: 88-7970-200-9.
di Alexander
Auf der Heyde
Recensendo
nel maggio 1831 l'edizione tedesca della Storia pittorica di Luigi
Lanzi, lo storico Alfred von Reumont corregge una svista un po' imbarazzante
del curatore Johann Gottlob von Quandt secondo cui Pietro Benvenuti era
già scomparso: in realtà il pittore aretino in quel momento
godeva di ottima salute (e morirà tredici anni dopo). Una curiosa
coincidenza, visto che dopo la scoperta dei suoi affreschi nella Sala
d'Ercole di Palazzo Pitti (1829) s'intensificavano le voci diffuse
per la prima volta nel 1822 secondo cui il linguaggio di Benvenuti era
troppo astratto; ricco sì di riferimenti alla cultura figurativa
del passato, ma incapace di dialogare con un pubblico i cui gusti si andavano
ormai modificando: la pittura non doveva più educare attraverso
degli exempla virtutis, bensì attraverso il coinvolgimento
emotivo dell'osservatore.
Fu questo l'inizio di una lunga sfortuna critica, protrattasi fino agli
anni Sessanta del secolo scorso, quando Carlo Del Bravo individuò
il maestro aretino fra gli interlocutori toscani di Ingres (1968) curando
l'anno successivo una pionieristica rassegna monografica sul pittore,
di cui in quel momento era concepibile presentare soltanto la produzione
grafica. A parte lo sporadico interesse (anche collezionistico) di compatrioti
aretini come Mario Salmi, iniziavano così le ricerche sul pittore
neoclassico ben presto approfondite dalle ricognizioni sistematiche di
Sandra Pinto e dagli studi di Klaus Lankheit, il quale, consapevole della
fama europea del maestro, analizzava nuovi materiali rinvenuti fuori dall'Italia.
Contributi significativi si devono inoltre ad Ettore Spalletti (1992)
che illustra la cultura romana dell'artista attraverso il complesso intreccio
linguistico di stampe flaxmaniane e rilievi di Thorvaldsen.
Sono queste le premesse da cui le ricerche di Liletta Fornasari sono partite
e nell'arco di otto anni - dal 1996 fino ad oggi - la studiosa ha pubblicato
una serie di interventi portando alla luce un'impressionante quantità
di materiali inediti fra disegni, dipinti e documenti. Il presente volume
nasce, dunque, da ricerche quasi decennali volte alla ricognizione del
territorio aretino, in cui sono rimaste numerose tracce dell'attività
artistica di Benvenuti. Emerge, infatti, il profilo a tutto tondo di un
artista, dai suoi primi studi svolti sulla base di testi per lo più
appartenenti alla tradizione seicentesca locale (Furini, Martinelli, Allori,
Dandini), all'importante soggiorno romano (1792-1804) dove frequenta lo
studio di Antonio Cavallucci - fase che lascia le sue tracce nella prima
opera significativa, il Martirio di San Donato ad Arezzo (1794).
Naturalmente il giovane Benvenuti dovette ben presto immergersi nel vivace
ambiente artistico romano, così ricco - nonostante le spoliazioni
napoleoniche - di suggestioni antiche e rinascimentali, di cenacoli poco
ortodossi come la cosiddetta "Accademia de' Pensieri" di Felice
Giani, dove artisti di varia provenienza si esercitavano nella composizione
di soggetti letterari. Fu sempre a Roma, grazie anche all'aiuto di generosi
committenti come l'irlandese Lord Bristol, che l'artista riuscì
ad elaborare - in opere come la Giuditta con la testa di Oloferne
(1798, 1804) - un linguaggio limpidamente classico, che unisce una grammatica
gestuale di matrice raffaellesca ad esercizi stilistici di vario genere,
svolti su fonti antiche e moderne. Tornato a Firenze con la fama di restauratore
della pittura toscana, Benvenuti assunse nel 1804 la direzione dell'Accademia
fiorentina, incarico che ricoprì per ben quarant'anni, fino alla
morte avvenuta nel 1844. Nei primi anni fiorentini, in opere come Elisa
Baciocchi e la sua corte oppure Il giuramento dei Sassoni (1811-12)
l'artista mette alla prova le proprie qualità "propagandistiche"
divenendo, di fatto, una sorta di portavoce figurativo delle ambizioni
politiche e culturali dell'impero napoleonico in Toscana. Ormai saldamente
inserito nelle istituzioni artistiche fiorentine, il passaggio di potere
con la Restaurazione dei Lorena non dovette procurargli grandi problemi;
mantenne, infatti, il proprio ruolo di direttore accademico, continuando
persino a lavorare alla decorazione della Sala d'Ercole (1817-29),
concepita ai tempi del dominio napoleonico. Seguono altre decorazioni
monumentali come gli affreschi della Cappella dei Principi (1828-36),
che suscitarono non poche perplessità persino da parte dei critici
"fedelissimi" come Giovanni Rosini, mentre nell'ambiente più
raccolto del salotto di Carlotta Lenzoni si concedeva un avveduto avvicinamento
alle poetiche del Romanticismo storico cui il suo entourage fiorentino
aveva dichiarato la guerra.
Grazie alle ricerche d'archivio condotte dall'autrice è ora possibile
datare con maggiore precisione i dipinti, nonché ricostruire i
rapporti stretti con personalità importanti quali Canova e Thorvaldsen.
Per meglio comprendere il funzionamento dell'Accademia fiorentina all'interno
di un intreccio istituzionale complesso e di scarsa trasparenza non si
può certo prescindere dall'"ingombrante" e prepotente
personalità di Benvenuti, le cui attività del resto non
si limitavano a questioni didattiche: si pensi ai suoi viaggi a Roma dove
acquista dipinti antichi destinati alle Gallerie fiorentine, o alle imprese
calcografiche che, da lui dirette, erano finalizzate alla divulgazione
del patrimonio artistico locale (1819: I monumenti sepolcrali della Toscana;
1822: La Galleria Riccardiana).
Resta soltanto il rammarico che la cura editoriale del volume non sia
all'altezza degli sforzi dell'autrice: gli apparati sono troppo ridotti,
non agevolano il lettore nella consultazione del volume, ma soprattutto
la qualità delle immagini non rende giustizia alle qualità
artistiche della sua pittura. Nondimeno, la monografia costituisce per
gli studi ottocenteschi un importante strumento grazie al quale possiamo
ripercorrere le vicende di uno dei suoi indiscussi protagonisti.
|