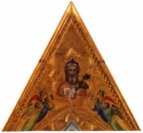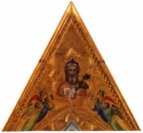|
Interpretazione e comunicazione dell'arte medievale: nuovi problemi e
nuove possibilita'
di Valerio
Ascani
In
questo contraddittorio inizio di secolo, malgrado i megafoni della comunicazione
di massa puntino con affabulante insistenza altrove, spinti anche dall'incalzare
di eventi drammatici, l'interesse dei cittadini in Italia e nel resto
d'Europa verso l'arte e la cultura del passato - e, nella fattispecie,
del millennio medievale - sembra registrare un costante aumento, almeno
a giudicare dal numero di libri, siti, iniziative dedicati in qualche
modo alla riscoperta dell'Europa medievale. Una curiosità culturale
che solo in parte è possibile ritenere alimentata dai risultati
della ricerca scientifica nel settore e che più generalmente coinvolge
tutti i risvolti dei modi di vita e della cultura del mondo medievale,
di cui vengono colti soprattutto gli aspetti - veri o presunti - in cui
l'uomo contemporaneo può più agevolmente rispecchiarsi:
incertezza politica, fermenti sociali, spirito di viaggio, sforzo ricostruttivo,
anelito di crescita spirituale. Lungi dall'aspirare a condurre una disamina
di questi complessi argomenti, questa nota intende solo porre l'accento
sui rapporti tra le tendenze dell'interpretazione scientifica del mondo
artistico medievale e le nuove caratteristiche della percezione che di
quella stessa realtà paiono emergere nella società odierna,
che dei risultati della ricerca è peraltro destinataria.
In un tessuto culturale sempre più intricato e variegato a dispetto
di forti voci uniformanti, e in presenza di nuove tecniche e strumenti
di comunicazione, in primis internet, che hanno permesso una inedita forma
di frammentazione e riconduzione alla sfera personale delle fonti di informazione,
anche il rapporto con la produzione artistica del passato e con i testi
monumentali oggi visibili ha acquisito una dimensione più diretta,
non mediata dalla critica e dalla storiografia, se non per la formazione
ricevuta dai singoli osservatori e le informazioni che essi possono avere
ricavato da pubblicazioni specifiche, libri, cataloghi di mostre, cd-rom.
Prevale, anche come metodo di approccio culturale, l'osservazione e la
fruizione diretta, spesso poco o per nulla supportata da letture opportune.
Per rendersi conto di questo basta solo rilevare in un museo o davanti
a una cattedrale la percentuale di visitatori muniti di guide o di libri
specialistici rispetto ai visitatori che si affidano unicamente alla propria
osservazione e al proprio bagaglio culturale. E molto spesso, soprattutto
nel turismo di massa, tale bagaglio è costituito soprattutto da
un catalogo di immagini, come una raccolta di cartoline di cui si cerca
di riconoscere i soggetti dal vivo con un gioco di memoria visiva, e spesso
si lascia esaurire in questa agnizione il proprio rapporto con l'opera
d'arte.
A fronte di tutto ciò si assiste, ad un livello ben diverso, alla
organizzazione di mostre o alla comparsa di testi che sollecitano un approccio
molto più profondo e scaltrito con l'opera d'arte, ma che a volte,
malgrado un apparente successo di numeri, non riescono a influenzare le
dinamiche del rapporto tra osservatore ed opera, e a suggerire un metodo
di lettura del testo monumentale. C'è da chiedersi quanti dei visitatori
di una mostra leggano per esteso i tabelloni introduttivi alle singole
sale o sezioni, o comprino e leggano approfonditamente il catalogo, e
quanti invece non si limitino a cogliere l'opportunità dell'esposizione
di quadri mai visti unicamente per colmare una pur legittima curiosità
e sete di nuovi spunti visivi, arrivando a giudizi soggettivi in cui preparazione
culturale e gusto sono messi alla prova, ma mancando la possibilità
di un contatto più formativo con le novità scientifiche
del settore.
Difronte a questo progressivo cambiamento di pubblico davanti ai quadri
di una esposizione negli ultimi decenni, c'è da chiedersi se la
formulazione delle mostre e dei libri scientifici destinati al grande
pubblico sia corretta e soprattutto efficace. E questo in special modo
nella metodologia e negli obiettivi che i curatori e gli autori si prepongono.
Una buona percentuale delle mostre di opere d'arte del Medioevo organizzate
negli ultimi anni sono state caratterizzate dall'intento di celebrare
un singolo grande artista e hanno proposto opere a lui avvicinabili su
basi soprattutto stilistiche e a fini sostanzialmente attribuzionistici,
spostando - in assenza dei pochi nuovi e fortunati ritrovamenti - alcune
opere dall'uno all'altro dei nomi presenti all'interno di un ventaglio
per il solito proposto dalla critica degli ultimi decenni. Un'operazione
legittima e certo in linea con le metodologie più auliche della
materia, ma forse ormai non del tutto in sintonia con gli interessi dei
visitatori.
Indubbiamente, organizzare un'esposizione di opere d'arte - in particolare
medievali - oggi è impresa sempre più difficile. Occorre
considerare in via preliminare che la stessa fenomenologia della materia
offre un numero non inesaurible di opere d'arte mobili rispetto a quelle
inserite stabilmente nel contesto per cui furono prodotte, come sculture
architettoniche o affreschi, che costituiscono una buona percentuale degli
elementi di interesse dell'arte del Medioevo. Inoltre, la particolare
metodologia di produzione dell'arte medievale contempla in molti casi
una lavorazione collettiva o in ogni caso a più fasi e più
mani della stessa opera, cosa che mal si accorda con i canoni di fruibilità
del capolavoro personale e puro quale spesso si intende porre all'osservazione
di un vasto pubblico. Infine - ma si tratta di problema non di poco conto
- l'enorme aumento delle spese di trasporto e di assicurazione delle opere
d'arte in questo periodo tristemente segnato anche da vigliacchi attacchi
al patrimonio artistico, i conseguenti dinieghi da parte di numerose istituzioni
internazionali al prestito, e la carenza di finanziamenti data dalle diminuite
disponibilità di banche e altri possibili finanziatori rendono
quasi proibitiva l'organizzazione di una mostra che non preveda - come
nel caso della Storia dell'arte moderna e contemporanea - un sicuro rientro
economico e di immagine grazie al richiamo esercitato dai grandi e celebri
nomi di artisti spendibili.
E' un peccato che non si colga tuttavia a questo punto l'opportunità
suggerita dal 'basso' per ovviare a questo gap tra gli interessi scientifici
e quelli divulgativi della materia. Ci sono infatti numerosi campi e occasioni
in cui le ragioni dell'interpretazione e quelle della comunicazione dell'arte
medievale possono coincidere. Il fiorire di siti, pubblicazioni, la gemmazione
di esposizioni minori e finanche manifestazioni e giochi di ruolo sul
fenomeno artistico medievale, spessissimo carenti di una corretta base
storica, tecnica e culturale, suggerisce la possibilità per la
critica di intervenire su argomenti diversi da quelli legati all'analisi
stilistica di opere o alla delineazione di singole personalità
artistiche. Non solo l'esplorazione di ambienti artistici locali - argomento
certamente non nuovo alla critica e frequentato con rinnovate capacità
analitiche negli ultimi decenni - appare di maggiore interesse per il
pubblico, ma anche l'introduzione ad argomenti tecnici oppure iconografici,
la ricostruzioni di contesti culturali di ambiti specifici della società
medievale o il confronto comparatistico tra opere d'arte collegate dai
numerosi itinerari artistici medievali attraverso l'Europa sono temi su
cui ben raramente sono sinora state tentate grandi esposizioni, perlomeno
in Italia, ma che il buon successo di libri, i numerosi convegni sull'argomento
e alcune esposizioni, talune anche di carattere storico e documentario,
rendono ben possibili.
E' auspicabile che gli operatori dell'esegesi scientifica dell'arte medievale
sappiano sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie
anche per un maggiore successo della comunicazione dei risultati delle
proprie ricerche, non solo nell'affiancare sezioni multimediali alle proprie
esposizioni e pubblicazioni, ma anche, in prospettiva, nel far sì
che sempre più le banche dati in rete, i forum o i gruppi tematici
e i nuovi esempi di social network, i siti delle università e delle
istituzioni scientifiche, compresi soprintendenze, musei e organismi culturali
degli enti locali costituiscano anche fonti di informazioni e documentazione
utili e accessibili, anche a livello internazionale, ponendosi anche come
centri di discussione e confronto sui temi che ci interessano.
In questo senso, la palestra costituita, soprattutto per i colleghi delle
più giovani generazioni, da una rivista scientifica in rete penso
possa esemplificare al meglio una delle possibili vie per colmare questo
vuoto comunicativo cui si alludeva tra ricerca ed esigenza di informazione,
e compiere un passo utile anche al fine di rinnovare i canali della divulgazione
delle scienze dei beni culturali per motivare un sempre maggiore interesse
alle tematiche della materia e correggere i già evidenti problemi
creati da questa carenza di contatto come l'improvvisazione e il bassissimo
livello scientifico di larga parte dell'informazione nei nuovi media,
ma anche nel giornalismo tradizionale, relativa ai temi dell'interpretazione
delle opere d'arte, in particolare di un periodo come quello medievale,
riscattato ormai da un buon secolo dalle fitte e scure nebbie in cui lo
aveva cacciato la storiografia del passato ma ancora evidentemente incrostato
di luoghi comuni e false certezze da rimuovere.
Aggiustando il tiro sugli obiettivi e le strategie comunicative della
propria ricerca alla luce dei problemi che si è cercato di esporre
è possibile che gli storici dell'arte medievale potranno nei prossimi
anni recuperare una funzione più centrale nei processi culturali
in atto e quindi contribuire maggiormente e con rinnovata incisività
a nutrire e qualificare il rapporto di interesse che le nostre generazioni
hanno sviluppato verso un età in cui riconoscono originarsi molte
delle proprie radici.
Torna all'inizio
|