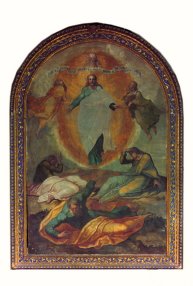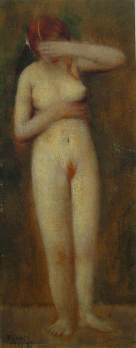|
"Sogni e Conflitti.
La dittatura dello spettatore" 50esima Esposizione Internazionale d'Arte.
Venezia, 16 giugno
- 2 novembre 2003.
di Alberto Salvadori
Si è aperta la cinquantesima
Biennale di Venezia, storica edizione, a cura di Franceso Bonami, dal
titolo Sogni e Conflitti. La dittatura dello spettatore.
L'edizione della "Grande Mostra", come la definisce Bonami, offre un panorama
estremamente variegato del mondo e della realtà, elaborati, trasformati
e immaginati dagli artisti.
La presenza di ben undici curatori, lasciati liberi dal direttore artistico
di operare le proprie scelte personali e progettare spazi autonomi, rende
questa Biennale unica rispetto alle precedenti. Tale scelta non impedisce
una visione unificante all'interno delle diverse sezioni in cui è suddivisa
la mostra, dove i conflitti appaiono la tematica dominante.
Conflitti intesi come qualunque sistema, segnato da diseguaglianze, facente
parte del mondo contemporaneo: se infatti tutti i testi in catalogo rammentano
la situazione irachena, non è solo la guerra la questione nodale su cui
si intende riflettere.
Lo stesso criterio di omogeneità multiforme spetta ai Sogni, trasformati
quasi in una domanda che si pongono tutti i curatori: lo spazio e il ruolo
che può e deve assumere l'espressione artistica all'interno dei quotidiani
conflitti a cui assistiamo, questo il sogno, e in parte l'Utopia - come
recita il nome di una sezione della mostra -, di chi fa arte. Inevitabile
forse, ma netta, la percezione di una certa debolezza nella visita alla
mostra, passando da una sezione all'altra, dove il livello delle opere
e delle scelte curatoriali subisce variazioni di intensità e qualità notevoli,
talvolta ammiccando un po' troppo al mercato (vedi la mostra al Museo
Correr).
Se un merito va comunque ascritto a Bonami e alla sua Biennale, quello
di avere cercato, e trovato, la complicità del grande pubblico - inteso
come massa -, è stata però tralasciata una solida e approfondita analisi
critica delle opere.
Nonostante la scelta di una tematica potenzialmente efficace e significativa,
la ricognizione panoramica della realtà sotto molteplici punti di vista
riflette il frenetico mondo della produzione artistica, il quale non si
presta, data la mole e la velocità di produzione, ad essere letto attraverso
una prospettiva storica e critica.
La parola d'ordine sembra essere consumare; consumare un'esperienza fugace,
complessiva, emozionale, che difficilmente dà spazio ad altre sensazioni
e che ancor più difficilmente lascia il tempo alla meditazione ed alla
riflessione.
Difficile tracciare un percorso preferenziale tra le opere, data l'ampiezza
dell'esposizione. Momenti di grande intensità offre la visita all'Arsenale,
grazie agli artisti africani presenti nella sezione Smottamenti,
a cura di Gilane Tawadros, dove La piste d'atterissage di Kader
Attia ci mostra, portandoci nella realtà dell'esperienza vissuta della
globalizzazione, i suoi "non-cittadini", privati di fiducia e di diritti,
in questo caso travestiti e transessuali algerini, emigranti e sans
papiers, accanto alle potenti immagini - purtroppo solo alcuni still
frames, presentati in light box, del superbo video presentato
all'ultima Documenta - di Zarina Bhimji, testimonianza di migrazione
ed esilio, eliminazione e cancellazione; memori degli eventi recenti del
Kosovo e del Ruanda.
A Catherin David si deve invece l'affascinante progetto a lungo termine
Rappresentazioni Arabe Contemporanee con le presentazioni, le conferenze
e gli spettacoli che vedono coinvolti vari autori con il fine di consolidare
e incoraggiare la produzione, la circolazione e lo scambio di idee, fra
i diversi centri della società araba e il resto del mondo.
La visita all'Arsenale termina alle Tese con la sezione più stimolante
e incoraggiante: Utopia Station curata da Molly Nesbit, Rirkrit
Tiravanija e dal vulcanico Hans-Ulrich Obrist. La Stazione è concepita
come luogo di passaggio, sovrapposizione di molti strati, ognuno dei quali
si sviluppa in ritmi, momenti e luoghi diversi, animati, per tutta la
durata della Biennale, da seminari, incontri, manifesti e spettacoli,
con l'intento di creare, almeno a livello immaginario, uno spazio libero
e sicuro, partendo dalla premessa - assunta a vera e propria parola d'ordine
dai curatori di questa sezione - di Backminster Fuller che ha scritto
"oggi il mondo è troppo pericoloso per qualsiasi cosa, meno che per l'Utopia".
Ai Giardini domina la mostra del Padiglione Italia, Ritardi e Rivoluzioni,
dove Francesco Bonami e Daniel Birnbaum tentano un'excursus tra
i corsi e ricorsi della produzione artistica degli ultimi anni, intesi
come Ritardi ma anche possibili Rivoluzioni. Accanto La Zona, bel
progetto architettonico degli A12, spazio appositamente studiato per la
giovane arte italiana, che soffre però di una curatela, quella di Massimiliano
Gioni, debole e che viene meno ai suoi stessi obiettivi.
 D. Hirst, Untitled,
2001-02
D. Hirst, Untitled,
2001-02
Torna all'inizio
|