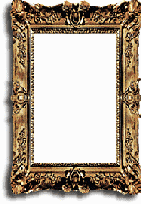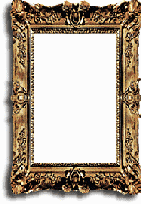|
Udine: i nuovi
sentieri dei beni culturali in Italia
di Emanuele Pellegrini
Il 27 e 28 maggio
2003 si è tenuto presso l'Università di Udine un convegno dal titolo I
nuovi sentieri dei beni culturali in Italia: tra storia, economia e legislazione,
promosso dall'Associazione Maiè formata dai dottorandi e dagli specializzandi
in Storia dell'Arte di quell'ateneo.
I lavori sono stati introdotti da
Donata Levi che ha individuato le ragioni di questa iniziativa nel tentativo
di istituire un maggiore raccordo tra l'università - e l'ambito della
ricerca ad esso connesso - ed il sistema di tutela dei beni culturali,
la cui gestione è stata negli ultimi tempi toccata da un radicale riassestamento,
giuridico ed amministrativo.
I recenti provvedimenti legislativi, infatti,
hanno portato ad una sottomissione dell'aspetto culturale e - in casi
sempre più frequenti - anche della tutela dell'oggetto artistico a fronte
di interessi precipuamente economici; una soluzione di continuità nel
sistema della conservazione dei beni culturali in Italia.
Salvatore Settis,
autore del primo intervento, ha precisato due punti chiave: le recenti
complesse problematiche non sono un italian job, nel senso che esse avranno
ripercussioni importantissime all'estero, in quanto l'Italia ha sempre
avuto un ruolo guida nel settore della tutela; e, secondariamente, ribadendo
quanto già chiaramente espresso nel suo recente volume Italia S.p.a.,
egli ha spiegato che ci troviamo di fronte agli esiti di un processo che
affonda le proprie radici nelle precedenti legislature, sebbene ora profondamente
radicalizzato. Nel ripercorrere per tappe significative la legislazione
degli stati italiani prima dell'unificazione, sì come nell'evidenziare
la peculiarità italiana nel legame tra museo e territorio, Settis ha sottolineato
come il sistema artistico abbia sempre rivestito funzione civile e non
patrimoniale.
Giulio Volpe poi, secondo relatore, ha specificato l'assoluta
imprescindibilità del carattere storico dal concetto di bene culturale,
riconoscendo in due dei postulati cardini della legislazione in materia,
l'inalienabilità ed il divieto di smembramento, principi costitutivi fondamentali.
Volpe ha incentrato la propria argomentazione sul rapporto Stato-Regioni,
altro momento delicato nel dibattito di questi mesi, riconoscendo anche
in questo caso un processo di più generica riforma che prevede l'allocazione
delle funzioni amministrative all'ente più vicino al cittadino (principio
di sussidiarietà), auspicando un più diretto coinvolgimento, non solo
delle Regioni, ma anche dei Comuni. Se riferito ai beni culturali il problema
diviene evidente soprattutto nei conflitti di competenze che si possono
instaurare tra queste entità, soprattutto ora che la presenza dell'Agenzia
del Demanio e delle Scip (Società di Cartolarizzazione degli Immobili
Pubblici) richiede chiarezza intorno a chi deve essere il referente primario
nell'identificazione delle caratteristiche di alienabilità di un bene.
Il professor Losavio, terzo relatore, si è concentrato proprio sulla centralità
del concetto di inalienabilità, dimostrando gli effetti deleteri insiti
nella pericolosa deriva del concetto di in vendibilità - cui è strettamente
connesso il problema della tutela - nella successione dei provvedimenti
legislativi e dei relativi regolamenti presentati negli ultimi cinque
anni. Nel fornire alcune esemplificazioni, come la messa in vendita della
Manifattura Tabacchi di Modena, è tornato ad insistere sul rischio di
amputazione del patrimonio storico artistico della nazione. Nell'ultima
relazione della prima giornata l'economista Bernardi ha dimostrato che
il punto di partenza di un economista è "strumentale", ossia il momento
economico è un mezzo al servizio di qualunque fatto umano, insistendo
sulla scarsa opportunità di contrapporre pubblico e privato; e, dato fondamentale,
ha ribadito che gestire in maniera economicamente produttiva un museo
non significa portare i bilanci dal rosso al verde, bensì far funzionare
adeguatamente il servizio in gestione, in relazione al suo ruolo, che
è propriamente culturale. La scelta fra i relatori di un economista ha
permesso di confrontarsi con punti di vista spesso negletti e che potrebbero
finire invece per essere prevaricanti; da qui la necessità di conoscere
argomenti apparentemente estranei al bene culturale.
Il momento di più
difficile condivisione per i pochi umanisti operanti nel settore dei beni
culturali arriva quando la ricerca scientifica è posta sullo stesso livello
del management; se convivenza è giusto che sia, è altrettanto evidente
che i due aspetti non possono essere posti sul medesimo piano.
I lavori
della mattinata successiva sono stati dedicati alla relazione dei giornalisti
Buono e Ricciardi e alla presentazione del sito www.patrimoniosos.it da
parte di Marzia Bonfanti. I primi, che eseguirono un reportage televisivo
sulle Scip per la trasmissione di Rai Tre Report, hanno documentato i
danni ingenti che provocherebbe la dismissione di beni culturali ritenuti
di non particolare importanza in talune aree geografiche, specialmente
per quello che concerne i beni paesistici. La presentazione del sito ha
rivelato un'altra esperienza sul campo originata dall'allarme innescato
dai provvedimenti legislativi in materia di "patrimonio" culturale dell'attuale
governo: un'"osservatorio" sulla rete che, dall'autunno del 2002, segue
gli sviluppi della vicenda dei beni culturali in Italia, offrendo un aggiornamento
bibliografico continuo (rassegna stampa, recensioni) e numerosi spazi
per dibattiti e confronti (comunicati delle associazioni, interventi di
esperti del settore).
La discussione che è risultata al termine dei lavori
non ha potuto che riflettere il sostanziale disagio degli "addetti ai
lavori", come emarginati dal loro stesso settore di competenza. Ma è proprio
questo il nodo centrale della questione: la partita si gioca anche sul
recupero della coscienza che la ricerca scientifica non è disgiunta dalla
tutela e dalla gestione del territorio italiano. Si tratta, in sostanza,
di recuperare l'insegnamento di molti dei maestri della storia dell'arte
italiana, da Brandi ad Argan, per far sì che gli eremitaggi della ricerca
non conducano ad una sostanziale esautoramento di coloro che dovrebbero
essere i responsabili primi della gestione e della tutela dei beni culturali
in Italia. Anche per riscattare quella perdita di incisività che, ad un
livello istituzionale, si registra nell'inesorabile asservimento del Ministero
dei Beni Culturali a quello dell'Economia.
|