|
In mostra
|
Incontri
|

|
||||||||||||
 |
||||||||||||
|
Cinema e teatro
|
||||||||||||
|
Segreti
di Stato - dalla sceneggiatura alla distribuzione, cronache dall'interno di Gianpaolo Smiraglia Assistere alla genesi di un film Quando
ho cominciato a collaborare con Paolo Benvenuti, nel maggio 2001, erano
ormai diversi anni che erano cominciate le ricerche storiche necessarie
per poter ricostruire la complessa trama che dava corpo alla vicenda di
Portella della Ginestra. Un pomeriggio a casa sua erano riuniti alcuni
amici, in gran parte allievi dei suoi primi corsi di cinema e fidati collaboratori
nella realizzazione dei film. Aprirono davanti ai miei occhi un grande
schema in cui comparivano una gran quantità di personaggi divisi
per gruppi; era in pratica una griglia leggibile in verticale come in
orizzontale: su un asse leggevo lo svolgersi dei fatti secondo una successione
di eventi all'interno di un certo gruppo (il passaggio di consegne da
un membro all'altro di un partito, ad esempio), mentre sull'altro venivano
evidenziati l'infittirsi dei collegamenti tra personaggi di diversi gruppi,
via via che gli eventi si avvicendavano. Mi chiesero se riconoscevo alcuni
dei nomi scritti, e se comprendevo lo svolgersi dei fatti. Molti erano
i nomi noti, che si muovevano in un intreccio di relazioni con altri assolutamente
a me sconosciuti. Quel compendio, nonostante semplificasse efficacemente
la lettura, dava la misura di quanto complicata poteva risultare la narrazione
dei fatti attraverso una finzione cinematografica. Il metodo del togliere Questo
metodo del togliere non è estraneo al lavoro di Benvenuti, anzi,
ne è componente essenziale. La necessità di spogliare la
rappresentazione cinematografica di ogni elemento distraente è
stata una linea guida durante tutta la lavorazione del film. Durante l'approntamento
delle scenografie ogni elemento era minuziosamente scelto al solo scopo
di creare ambienti veri, senza nessun compiacimento nell'arredamento d'epoca.
I sopralluoghi nel carcere di Gaeta avevano dato esito positivo proprio
per il senso che avevano quei muri scrostati, poco altro si è dovuto
aggiungere. Durante le riprese il lavoro sugli attori, come già
lo era stato per le scene, si concentrava al massimo sull'eliminazione
di ogni tipo di enfasi; la recitazione non aveva il ruolo di catapultare
lo spettatore in una immedesimazione, ma di sviluppare l'indagine. Agli
attori veniva richiesto il massimo contenimento possibile in relazione
al personaggio rappresentato. Lasciare che l'interpretazione dell'avvocato
o del perito suo collaboratore andasse oltre l'espressione del lavoro
di indagine avrebbe significato dar luogo ad una caratterizzazione non
utile, mentre i personaggi di Pisciotta, Cacaova, ed anche del professore
che nella parte finale del film apre gli occhi all'avvocato con il gioco
delle carte, pur se animati da una recitazione controllata, dovevano necessariamente
risultare più intensi, in quanto più o meno direttamente
coinvolti e colpiti dai fatti narrati. In ogni caso nessun elemento doveva
avere il primato sullo svolgersi dell'inchiesta, il solo argomento che
doveva catalizzare l'attenzione. Montaggio schietto Analogamente,
in montaggio, ogni sforzo andava in questo senso; la costruzione del film
non ammetteva in nessuna sua parte una tensione occulta. Come poco era
concesso al timbro e ai gesti degli attori, altrettanto limitata era la
libertà del montatore, non era concessa nessuna invenzione che
potesse in qualche modo privare il film del suo personale slancio: la
ricerca di una possibile verità. L'unica tensione riconosciuta
era quella della ricerca, la caparbietà di chi vuole sbrogliare
una matassa, dunque gli unici espedienti ammessi erano quelli che potevano
aiutare lo spettatore a non perdere questo filo. La prima ipotesi di montaggio
era stata costruita seguendo le indicazioni della sceneggiatura, molto
precisa anche nel numero d'inquadrature; in seguito la preoccupazione
che le troppe spiegazioni, anziché chiarire le varie tappe dell'indagine,
ne rendessero oscuri i passaggi, rese necessario asciugare ulteriormente
lo sviluppo del ragionamento sul quale si basava la costruzione delle
ipotesi dell'avvocato e del suo collaboratore nella prima parte del film.
Il numero dei disegni originati dai racconti di Pisciotta (in stile anni
'50, ma anche questi volutamente cronachistici e privi del pathos
tipico del ricordo) fu ridotto. Il sopralluogo fatto a Portella dall'avvocato,
originariamente un'unica scena, fu diviso in due parti, in modo da distinguere
i due gruppi di testimoni e concedendo così più ampio respiro
al ritmo, con due esterni che spezzavano tutte le altre scene, girate
in interno. Infine la scena finale del gioco delle carte venne staccata
dal contesto da cui partiva, ovvero la ricostruzione finale della strage
sul tavolo dello studio del professore, separata da questa da una brevissima
scena nell'infermeria del carcere dell'Ucciardone. La fotografia Anche
nel dare le luci la scelta di Benvenuti fu molto attenta perché
venisse evitata ogni drammaticità. L'evento di cui si narrava era
talmente forte e carico di un suo dolore da non richiedere un'atmosfera
ancora più cupa. Anzi, in laboratorio la richiesta del regista
era di ricercare dei toni rasserenanti. L'obiettivo a cui mirava era ricreare
l'atmosfera delle prime pellicole a colori che la Ferrania produceva per
il cinema negli anni '50. Questa decisione venne presa una volta viste
le scenografie realizzate, per rispettare la verità che esse ispiravano.
Sino a quel momento l'idea di Benvenuti era stata di realizzare una fotografia
in bianco e nero, come il regista si era immaginato il film durante tutto
il periodo della ricerca storica.
|
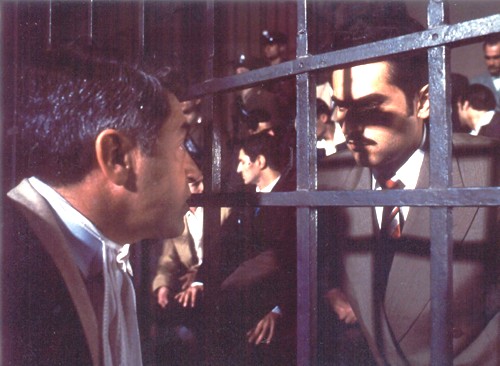 |
||||
|
Un fotogramma dal film Segreti di stato
|
||||