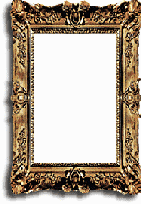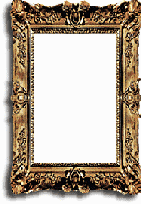|
Un convegno:
ibridazione di prospettive
di Denise La Monica
"Beni
culturali: prospettive e incognite del Nuovo Codice" è il
tema del convegno che si è tenuto a Pisa il 6 novembre 2003, organizzato
da alcuni dottorandi del Dipartimento di Storia delle Arti.
Principale obiettivo dell'incontro, significativamente richiesto da giovani
"addetti ai lavori", era delineare un quadro, quanto più
ampio e ricco possibile, dei punti di vista e dei pareri di una porzione
estremamente qualificata di personalità attive e competenti nell'ambito
dei Beni Culturali.
Progressiva erosione dello spazio di intervento dei "competenti"
e diffusione di una concezione del bene culturale come "giacimento"
o garanzia patrimoniale sono stati i presupposti su cui si è criticamente
impostata la discussione.
Nel corso della mattinata, hanno dato il loro contributo a proposito del
testo del Nuovo Codice, ancora allo stato di bozza, oltre ai docenti del
Dipartimento, anche personalità inserite in altri punti vitali
del tessuto sociale, amministrativo e politico, non solo universitario:
il senatore Giuseppe Chiarante, presidente dell'Associazione Bianchi Bandinelli,
profondo conoscitore della legislazione in materia; Cristina Acidini,
soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure, Marisa Dalai Emiliani,
ordinario di Storia dell'arte moderna dell'Università "La
Sapienza" di Roma, che hanno di volta in volta messo in luce aspetti
diversi di un'unica intrecciata problematica.
La
concezione "mercantilistica" di cui è vittima il Patrimonio
nella politica dell'attuale governo si realizza per Chiarante attraverso
il doppio binario del silenzio-assenso e dell'accelerazione della campagna
di alienazione e privatizzazione.
La centralizzazione autoritaria dell'imposizione dei vincoli e del relativo
sistema dei ricorsi, il conflitto di competenze tra Regioni ed Enti locali,
l'alleggerimento delle strutture tecnico-scientifiche del Ministero corrispondono
ad un pericoloso assottigliamento del livello di tutela. Su un altro versante,
l'abrogazione del DPR 283/2000, l'implementazione nel Nuovo codice dei
meccanismi della "verifica" (art. 12, per i beni pubblici) e
della "dichiarazione" (art. 13, per i beni privati), nonché
la ricorrente specifica della "particolare importanza" come
condizione per la salvaguardia di alcuni beni di proprietà non
pubblica, facilitano il percorso verso la dismissione dei beni mobili
e immobili.
Ampiamente
condiviso è il giudizio di "ambiguità" in relazione
allo statuto del restauro, che nel Nuovo Codice sembra oscillare tra attività
conservativa - e sottostimata - legata alla tutela, e operazione "promozionale"
- sponsorizzata e ben foraggiata - legata alla valorizzazione.
Altresì, la definizione del Museo (art. 101) come "struttura
permanente" che mira a "conservare" piuttosto che "esporre"
le proprie opere contrasta con la concezione delle Regioni che preferiscono
enfatizzare la funzionalità, l'attività di ricerca e di
comunicazione delle istituzioni museali.
Disorganica e non coordinata è parsa a Marisa Dalai, e non da ora,
la riforma del Ministero (D.L. 368/1998), in quanto sganciata da quella
dell'Università e delle strutture amministrative. La necessità
di parametri unitari per la definizione dei requisiti delle figure professionali
impiegate nell'apparato amministrativo è stata energicamente sottolineata,
contro la tendenza ad accettare, e perfino privilegiare, anche per settori
di particolare rilievo e di livello direzionale, bagagli curriculari di
non elevato profilo o di competenze non attinenti.
Come si poteva facilmente prevedere, l'incontro è stato un'utile
occasione di confronto in cui sono emerse numerose critiche al testo in
corso di elaborazione presso il Ministero, non solo sui contenuti, ma
anche sui modi e i tempi dell'iniziativa, che è parsa, a molti,
troppo fortemente centralizzata e "blindata".
Nel
pomeriggio il panorama degli interventi si è ulteriormente arricchito,
grazie all'intervento del prof. Salvatore Settis, Direttore della Scuola
Normale Superiore di Pisa, che, partecipando in prima persona alla stesura
del testo in qualità di consulente scientifico del ministro Urbani,
ha potuto fornire una testimonianza di prima mano sui modi e i tempi della
stesura del Codice.
Il suo punto di vista è quello di chi, accettando un'onerosa e
scomoda responsabilità, vede gli ingranaggi dall'interno del sistema
e si impegna per contenere i rischi di una rovinosa velleità legiferativa,
confrontandosi strenuamente con l'esecutivo. Ricordando (come già
nel suo fortunato pamphlet "Italia S.p.A.") che la deriva mercantilistica
della concezione dei beni culturali era già in atto fin dalla sfortunata
definizione di "giacimenti petroliferi" (ai tempi del governo
Craxi) e dall'uso della borghesisticamente incrinolita espressione "gioielli
di famiglia", Settis non rinuncia a continuare la sua opera di controllo
sul testo.
La distinzione tra tutela e valorizzazione, naturalmente inscindibili
per ogni "addetto ai lavori", è sancita dal Nuovo Codice
in due articoli (articoli. 3 e 6) e trova un valido contrafforte nella
Costituzione. L'art. 117. infatti, stabilisce che la "tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali" è ambito di legislazione
esclusiva dello Stato, mentre la "valorizzazione dei beni culturali
e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali"
rientra nella legislazione concorrente, per cui le Regioni detengono la
potestà legislativa.
In
effetti, per gli argomenti della valorizzazione e della fruizione il Nuovo
Codice mostra una tematizzazione più organica, forse più
completa e strutturata, pur ponendosi in un'ottica "quantificatoria"
tendenzialmente pericolosa. La necessità di una "regolamentazione"
nel settore delle alienazioni, seppure concettualmente aberrante, contestualmente
ad un'impronta auspicabile nella direzione della tutela, conservazione
e riqualificazione del patrimonio pubblico è imposta dall'emergenza
della volontà dell'esecutivo e dal confuso ipertrofismo normativo.
Voce discordante dal coro pressoché unanime è quella dell'unico
autorevole giurista intervenuto, Fabio Merusi, che ha arricchito il quadro
precisando alcuni fondamentali concetti giuridici. Facendo riferimento
agli art. 117 e 118 della Costituzione da cui discende la separazione
tra "tutela" e "valorizzazione", egli evidenzia che
il Nuovo codice cerca di soddisfare la necessità di una precisa
definizione della "titolarità" e della "gestionalità".
Riguardo ai procedimenti di verifica e dichiarazione il giurista, forse
provocatoriamente, tende a ridimensionare l'impegno richiesto alle Soprintendenze
e, per contrasto, conferisce particolare risalto ai concetti di "indifferenzialità"
e "circolarità" del patrimonio.
Specchio di questo panorama eterogeneo è il sito PatrimonioSos
(www.patrimoniosos.it), che è stato presentato da Donata Levi e
Marzia Bonfanti - la stessa Donata Levi aveva chiarito lo spirito e il
significato di questa importante e lodevole iniziativa nella Cuspide del
n. 8 di "Predella", cui si rimanda.
L'esperienza
del 6 novembre ha insegnato quanto possa essere proficuo un dialogo diretto
con esperti di ambiti diversi, e può essere considerato un modello
esemplare della metodologia da seguire per l'elaborazione di un testo
normativo per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico-artistico italiano, uno dei fondamenti della nostra tanto ricercata
identità nazionale.
Torna
all'inizio
|