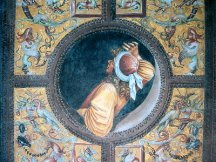|
La
fine del mondo secondo Angelico e Signorelli
di
Gerardo de Simone
C.
Gilbert, How Fra Angelico and Signorelli saw the end of the world,
The Pennsylvania State University Press, University Park (Penn.), 2003,
pp. XIX-200, $ 85.
Il
nuovo libro di Creighton Gilbert, dedicato alla Cappella Nuova o di San
Brizio nel Duomo di Orvieto, rivoluziona le più o meno consolidate
acquisizioni sul celebre ciclo di affreschi iniziato dall'Angelico e completato
da Luca Signorelli. La cappella, che fu edificata a partire dal 1406 "ad
similitudinem" della dirimpettaia Cappella del Corporale, non aveva
titolazioni ufficiali: nei documenti coevi viene infatti indicata genericamente
come "Cappella Nuova". La mancanza di dedicazioni sarebbe alla
base della scelta del Giudizio Finale come tema della decorazione, concordata,
come prova il contratto, con l'artista incaricato, il Beato Angelico.
A Orvieto preesisteva l'esempio del Giudizio del Maitani sulla facciata
del Duomo; inoltre, nella stessa Umbria, si possono ricordare gli affreschi
di Ottaviano Nelli e dei Salimbeni a Gubbio, di Paolo da Visso a Monteleone
di Spoleto, di Bartolomeo di Tommaso a Terni. L'Angelico da parte sua
aveva riproposto questo soggetto nella tavola per S. Maria degli Angeli
a Firenze. Coadiuvato da Benozzo e da altri tre assistenti, il pittore
eseguì nell'estate del 1447 le due vele con Cristo Giudice e angeli
e i Profeti. Contrariamente all'opinione corrente, che limita la responsabilità
ideativa dell'Angelico alle sole volte, Gilbert sostiene che a lui spetterebbe
il disegno dell'intera campata interna, incluse le pareti sottostanti,
unitariamente concepita per la rappresentazione del Giudizio. Il primo
contratto stipulato dagli operai del Duomo col Signorelli, nel 1499, richiede
infatti che venga rispettato il disegno dell'Angelico relativo a "dicte
Cappelle Nove medietas", a metà cappella, cioè, e sottolinea
l'assenza di disegno in merito all'altra metà, senza distinzioni
tra volte e pareti. Le barriere architettoniche si troverebbero così
scavalcate dalla superiore unità del soggetto. La principale conseguenza
dell'approccio di Gilbert è la rinuncia alla convenzionale lettura
in successione degli affreschi delle pareti, dalle Storie dell'Anticristo
in senso antiorario fino all'Assemblea degli Eletti, con l'assurda - eppure
invalsa fino ad oggi, tranne che in un breve studio del Riess - divisione
del Giudizio in momenti in realtà sincroni.
Nello zoccolo della campata interna, accanto a quelli di Dante, Virgilio
e Claudiano (con intorno scene tratte rispettivamente dai primi quattro
canti del Purgatorio, dal libro VI dell'Eneide e dal De raptu Proserpinae),
Gilbert individua il ritratto di Coluccio Salutati, circondato da episodi
ancora dal Purgatorio (canti V-VIII) e dai Quattro Libri delle
Fatiche di Ercole dello stesso Coluccio. Tutte le storie rappresentate
si riferiscono a discese nell'oltretomba: i parallelismi pagano-cristiani,
con la sussunzione della mitologia classica in un'ottica cristiana, sono
tipici del pensiero umanistico. La serie dei personaggi effigiati riprende
quelle di alcuni cicli civici fiorentini, da Palazzo Vecchio all'Arte
dei Notai.
Signorelli, distaccandosi dalle precedenti raffigurazioni del Giudizio,
non mostra l'interno dell'Inferno, ma si limita all'Antinferno con Caronte
e Minosse nella parte destra della parete d'altare, e ai gironi più
esterni nello zoccolo sottostante (If I-VIII): anche questa omissione
può spiegarsi ricorrendo a Coluccio, che nel quarto libro dell'opera
sulle fatiche di Ercole sottolinea la reticenza della Bibbia sull'aspetto
dell'Inferno e la nostra necessità per immaginarlo di ricorrere
ai poeti, i quali sono però da leggere allegoricamente. Il racconto
purgatoriale-infernale di Signorelli segue anche questa sottigliezza,
passando da scene narrative (Pg I-VIII, sotto l'Assemblea degli Eletti)
a scene allegoriche (Pg IX-XXXI, sotto la Chiamata), esattamente all'unisono
coi versi, puntualmente visualizzati, di Pg VIII (19-21) che invitano
il lettore ad aguzzare gli occhi di fronte al "velo sottile"
del vero.
I soggetti affrescati nella campata esterna rispondono all'esigenza, dichiarata
nei contratti, di proseguire la decorazione con temi correlati al Giudizio.
Il tema dell'Anticristo come preambolo al Giudizio compare già
in un opuscolo illustrato stampato nel 1496, in un affresco trecentesco
ravennate, nel dramma sacro coevo, nella Legenda Aurea: Signorelli combina
insieme gli episodi ricavati da tutte queste fonti (dall'ultima in particolare).
Nessun legame invece può ipotizzarsi, come sostenuto da molti commentatori,
con l'immaginario apocalittico. L'evidenza assegnata da Signorelli alla
Resurrezione della Carne, spostata alla campata esterna dalla canonica
posizione centrale, può essere letta in chiave di ortodossia antieretica:
i Manichei e i loro epigoni medievali davano al corpo una valenza negativa,
riservando alla sola anima il privilegio della resurrezione. Inoltre essi,
separando nettamente il bene dal male, negavano l'esistenza del Purgatorio.
Orvieto era stata a partire dal Duecento un pericoloso avamposto dei movimenti
ereticali entro i domîni papali. Non è forse un caso che
negli affreschi della cappella trovino spazio immagini riferibili all'intera
cantica del Purgatorio dantesco, nello zoccolo sotto l'Assemblea
e la Chiamata degli Eletti.
Signorelli ha tratto precisi, e finora sfuggiti, spunti da Filippino Lippi,
in particolare per le figure di eretici: tra questi il personaggio calvo
nel riquadro dello zoccolo sotto le Storie dell'Anticristo, circondato
da Storie di Lucrezia. Adiacente all'eroina romana, nell'arco di volta
della cappellina dedicata a S. Maria Maddalena, era un David a monocromo
oggi non più visibile ma ricordato dalle fonti, speculare alla
Giuditta sull'arco di volta della cappellina di fronte. Questa triade
esaltante le virtù civiche non è certo casuale e la sua
presenza en abîme è da Gilbert messa in relazione con l'illustre
casato orvietano dei Monaldeschi. Due Monaldeschi elargirono infatti sostanziose
donazioni per la decorazione della cappella, e due stemmi del casato campeggiano
simmetricamente agli angoli inferiori della volta, dal lato d'ingresso.
Il personaggio nello zoccolo sotto la Resurrezione della carne, già
creduto il poeta Lucano, è interpretato come campione di virtù
civiche, in virtù della corona di foglie di quercia: nel sesto
libro dell'Eneide ad Enea appaiono così coronate le anime dei suoi
discendenti in attesa di rinascere. Tra essi il più papabile per
l'affresco è Silvio Enea: un cifrato omaggio ad Enea Silvio Piccolomini,
papa Pio II (1468-74), che aveva visitato Orvieto nel 1459 e aveva combinato
il matrimonio tra un proprio nipote e una Monaldeschi. Attorno a Silvius
Aeneas sono scene di lotta tra uomini nudi tratte dalla Tebaide di
Stazio.
L'unico porporato ad avere legami diretti con Orvieto era all'epoca il
cardinale Alessandro Farnese (fu prima canonico, poi arciprete della Cattedrale).
Dotato di raffinata cultura umanistica, Gilbert lo considera l'indiziato
più autorevole per l'elaborazione del programma iconografico, nonché,
per gli stretti rapporti con i Medici, per la scelta dell'artista incaricato,
Signorelli. Che l'iconografo/promotore del compimento della Cappella Nuova
e il futuro committente del Giudizio di Michelangelo possano coincidere
è conclusione del massimo interesse. Al Farnese spetterebbe in
gran parte il merito sia della fedeltà al progetto angelichiano
del Giudizio - estesa fino a prestiti precisi come quello qui illustrato,
che si può segnalare a sostegno della tesi di Gilbert -; sia della
complessa illustrazione dell'Inferno e Purgatorio danteschi, inedita quanto
all'adozione del metodo allegorico, debitrice in questo del commento all'epoca
più in voga, quello del fiorentino Landino.
|