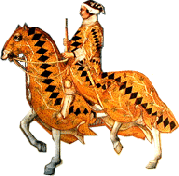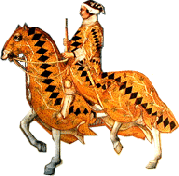|
Meraviglie
da Kunstkammer a Vienna
di Maria
Grazia Tagliavini
E'
una bellissima giornata di sole e la Maria-Theresien-Platz brulica di
turisti: il cielo limpido d'un azzurro intenso e la fresca brezza alpina
hanno completamente cancellato in me ogni ricordo del torrido agosto italiano.
Vienna è proprio come l'avevo immaginata: una splendida signora,
fiera dei propri tesori, alle prese con le memorie di un passato troppo
grande e glorioso. La visita all'Hofburg, il palazzo imperiale residenza
degli Asburgo dal 1283 al 1918, me ne ha dato conferma: è una sorta
di feticismo, quasi una devozione religiosa quella che, al di là
della pur evidente intenzione di catturare il turista a caccia di curiosità
e di souvenir, sembra legare i viennesi alle "reliquie" della
loro storia: i guanti e le spazzole con cui l'imperatrice Elisabetta di
Baviera era solita farsi pettinare, il calamaio e le carte di lavoro ancora
sparse sullo scrittoio di Francesco Giuseppe, l'ultimo imperatore.
Eppure, il ricordo di questi fantasmi del passato, evocati con nostalgia
da Joseph Roth nella Cripta dei Cappuccini e parte integrante della memoria
collettiva di un popolo, non offusca in alcun modo la gioia di vivere
dei viennesi: nelle strade, nelle piazze, nei caffè all'aperto,
nei mercatini si respira l'aria frizzante di una città gaudente
e spensierata.
Contagiata da questo spirito di festa, mi dirigo al Kunsthistorisches
Museum, che, costruito tra il 1871 e il 1891 nell'area della Ringstrasse
in un sontuoso stile neorinascimentale, ospita la massima parte delle
collezioni d'arte asburgiche. Subito decido di non seguire la folla di
turisti diretti sullo scalone verso il primo piano e, dunque, verso la
Pinacoteca stracolma di capolavori: Tiziano, Dürer, Rembrandt per
il momento possono attendere. La mia meta è la collezione di scultura
e di arti decorative, collocata nell'ala orientale del piano rialzato:
purtroppo non potrò ammirarla per intero, dal momento che, come
mi spiega in un inglese quasi perfetto una dipendente del museo, la gran
parte delle opere non sarà visibile al pubblico almeno sino alla
fine del 2004 per restauri in corso. Tuttavia, l'eccelso livello qualitativo
degli oggetti esposti riesce a dare un'idea della straordinaria ricchezza
della collezione, pur sfregiata nel maggio di quest'anno dal clamoroso
furto del suo pezzo più celebre, la Saliera del Cellini.
La collezione, tra le più complete e meglio documentate al mondo,
riunisce per lo più il patrimonio delle Kunstkammer asburgiche,
in particolare quelle dell'arciduca Ferdinando II (1529-1595) nel castello
di Ambras, dell'imperatore Rodolfo II (1552-1612) a Praga e dell'arciduca
Leopoldo Guglielmo (1614-1662) a Vienna. La grande varietà di tipi,
di materiali e di tecniche con cui sono realizzati questi oggetti, lavori
di oreficeria e di glittica, avori, bronzetti, ma anche arazzi, piccole
sculture in creta, ritratti in cera e pietre preziose, è perfettamente
in linea con le caratteristiche di una Kunstkammer principesca.
Concepita come un microcosmo che ruota intorno ai gusti e alle leggi del
sovrano, la Wunderkammer, o "stanza delle meraviglie",
riflette l'idea tipicamente manierista di metamorfosi, che, mettendo in
dubbio la razionale conoscibilità delle cose e dando forma al gusto
del bizzarro e dell'esotico, testimonia l'irrequietezza di una civiltà
in crisi. Dunque, accanto ai "naturalia" e ai "miracoli
fisici", come fossili e mostri animali e vegetali, ecco le "cose
artifiziose", nelle quali l'arte gareggia con la natura, spesso superandola
in bellezza e in perfezione e talvolta correggendone gli errori. E in
questo duello incessante tra realtà e finzione la magia e l'alchimia
rivestono un ruolo centrale.
Ed è così che mi sorprendo ad ammirare stupita un bezoar
(dal persiano "bad-sahr" che significa "antidoto"),
la secrezione ricavata dalle interiora di una capra asiatica e del lama
sudamericano ed apprezzata per la sua presunta capacità di assorbire
i veleni dalle bevande e di curare dalla melanconia: Rodolfo II, che negli
ultimi anni di vita teme che qualcuno possa avvelenarlo, fatto vuotare
il bezoar, intorno al 1600 incarica il suo orafo di corte Jan Vermeyen
di ricavarne una coppa grazie ad una montatura in oro smaltato. Virtù
magiche e terapeutiche sono riconosciute anche al raro e prezioso corno
di rinoceronte e alle cosiddette "lingue di drago", zanne fossili
di pescecane con cui vengono realizzate suppellettili da tavola, come
la coppa eseguita alla metà del XV secolo a forma di pianta in
cui le lingue di drago fungono da fiori.
Ancora più incredibile mi appare il boccale di uovo di struzzo
di Clement Kicklinger, eseguito ad Augusta tra il 1570 e il 1575: sulla
base decorata da spessi rami di corallo, in grado secondo la tradizione
di proteggere dal malocchio, un moro in argento dipinto tiene a una lunga
catena uno struzzo, che porta sul dorso un uovo e stringe nel becco un
ferro di cavallo. Il valore apotropaico è chiaro: il boccale ha
il potere di trasfondere nel bevitore la straordinaria forza dello struzzo,
ritenuto capace addirittura di digerire il ferro e le pietre.
A proposito di pietre: la vetrina successiva racchiude un oggetto che
a prima vista non riesco a definire. Si tratta di un Handstein,
"pietra grande come una mano", una specialità dell'arte
orafa boema: un campione minerario, lavorato e decorato con minuscole
statuine d'oro o d'argento, viene trasformato in un pezzo di virtuosismo
da collezione, che in questo caso raffigura una Resurrezione ispirata
alla xilografia düreriana del ciclo della Grande Passione.
E se con la coppia di vasi a forma di aironi in cristallo di rocca della
celebre bottega milanese dei Saracchi, dalle trasparenze e dai giochi
di luce tanto apprezzati anche dai granduchi della dinastia medicea, per
un attimo respiro aria di casa, con il Trionfo di Bacco in argento dorato,
realizzato ad Augusta nel 1605 circa, mi rituffo nell'atmosfera gaudente
della corte rudolfina. In questo capriccioso gioco conviviale un meccanismo
interno consente al carro di spostarsi da solo sul tavolo e alle figure
di compiere piccoli movimenti: Bacco solleva il braccio, il pappagallo
sbatte le ali e lo zampognaro si accinge a suonare il suo strumento, mentre
il capro può essere usato come coppa, svitandone la testa per permettere
ai convitati di bere il vino. Subito il pensiero corre agli automi del
giardino della villa medicea di Pratolino, espressione emblematica del
desiderio umano di sfidare la natura per mezzo di una tecnica estrosa
e spericolata. L'ultima opera che attrae la mia attenzione è un
vaso burlesco in creta smaltata di una fantasia e di una comicità
irresistibili: un beone a cavallo di una botte è sottoposto al
supplizio di Tantalo in mezzo a leccornie irraggiungibili disposte tutt'intorno
alla sua testa, che può essere svitata e usata come tappo. Ma i
convitati avranno davvero accolto l'invito alla moderazione, celato nell'ironia
di quest'oggetto stravagante?
Cfr.
immagine in copertina
|