|
In mostra
|
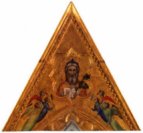
|
|||||||||||||
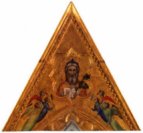 |
|||||||||||||
|
Cuspide
|
|||||||||||||
|
di Maria Ines Aliverti Le
esposizioni teatrali, in particolare quelle a carattere storico, sono
in Italia un fenomeno relativamente recente. Solo dopo il 1970, in due
centri di grande tradizione teatrale come Venezia e Firenze, si è
iniziato a valorizzare attraverso specifiche iniziative espositive il
patrimonio artistico teatrale, elaborando al contempo approcci altamente
innovativi nel campo della storia del teatro e della scenografia e nell'analisi
e interpretazione dello spazio teatrale: mi riferisco, come molti sapranno,
alle storiche esposizioni presso la Fondazione Cini curate da Maria Teresa
Muraro, Elena Povoledo e Franco Mancini e a quella famosissima ideata
da Ludovico Zorzi nel 1975 a Firenze (Il luogo teatrale a Firenze),
in collaborazione con Mario Fabbri, Anna Maria Petrioli Tofani ed Elvira
Garbero Zorzi. È indubbio che già negli anni precedenti
un forte impulso a una nuova concezione del patrimonio storico del teatro
era stato dato da quell'opera capitale e mai troppo lodata che è
la Enciclopedia del teatro e dello spettacolo (9 voll., 1954-1962)
diretta da Silvio D'Amico, vera e propria fucina in cui maturò,
a contatto con grandi studiosi stranieri (400 collaboratori stranieri),
la storia del teatro italiana (200 studiosi italiani) e che pose le basi
di una più approfondita conoscenza della cultura tecnica e materiale
del teatro, nonché della cultura artistica a esso relata. Come
osserva Paolo Puppa in un recente intervento (2001), con quest'enciclopedia
"si allargò a dismisura la geografia dello spettacolo".
L'enorme corpo illustrativo (700 illustrazioni nel testo, 1800 fuori testo,
320 tavole a colori) si offre al lettore come il primo grande e completo
museo cartaceo del teatro. In questi
ultimi anni si è assistito nel nostro paese a un intensificarsi
delle occasioni espositive correlate in varia maniera con il teatro e
con la sua storia. Accanto alle numerosissime mostre monografiche dedicate
a singole personalità di artisti: registi, attori, scenografi,
costumisti, fotografi teatrali, o a singole istituzioni teatrali di tradizione
storica, una serie di mostre tematiche hanno posto l'accento, con impostazioni
metodologiche diversificate, sui sempre intriganti rapporti che intercorrono
tra arti figurative e teatro. Ricordo, solo negli ultimissimi anni, la
mostra monografica su Eleonora Duse, a cura di Maria Ida Biggi, per il
50° anniversario della Fondazione Giorgio Cini a Venezia (2001-2002),
quelle dedicate ai Bibiena (Bologna 2000-2001, a cura di Deanna Lenzi
e Jadranka Bentini), e a Giacomo Torelli (Fano 2000, a cura di Francesco
Milesi), e alcune recenti iniziative fiorentine, quali l'accurata ricostruzione
espositiva della storia del Teatro della Pergola (Lo spettacolo meraviglioso,
2000), a cura di Marcello De Angelis, Elvira Garbero Zorzi et alii, e
la riedizione in formato ridotto di due grandi mostre del passato:
Teatro e spettacolo nella Firenze dei Medici. Modelli dei luoghi teatrali,
a cura di Elvira Garbero Zorzi e Mario Sperenzi, 2001, basata sui modelli
lignei approntati per la già citata mostra del 1975, e Pittori
del '900 al Maggio Musicale Fiorentino, 2003, a cura di Moreno Bucci,
riproposta della fondamentale rassegna sulle scenografie del Maggio ideata
alla fine negli anni Settanta da Raffaele Monti (Visualità del
Maggio, 1979). In questi giorni si è aperta presso la Fondazione
Ragghianti di Lucca l'esposizione dedicata a scenografie e costumi delle
opere pucciniane: La scena di Puccini, curata da Vittorio Fagone, direttore
dell'istituzione lucchese e da Vittoria Crespi Morbio, curatrice degli
archivi della Scala. In una direzione tematico-metodologica volta a investigare
i rapporti tra arte e teatro è ancora da notare l'approdo in Italia
delle esposizioni shakespeariane: dopo quella incentrata su Füssli
pittore di Shakespeare. Pittura e teatro (1775-1825) presso la Fondazione
Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo (1997), la recentissima Shakespeare
e l'arte, a cura di Jane Martineau e Maria Grazia Messina al Palazzo
dei Diamanti di Ferrara (2003), ora trasferita alla Dulwich Picture Gallery
di Londra, istituzione che con Ferrara Arte ha collaborato all'allestimento.
Accanto all'universo di Shakespeare, intorno al quale si concentra già
dal diciottesimo secolo gran parte del patrimonio della pittura teatrale
inglese, quello del nostro melodramma ha meritato di recente un approccio
espositivo di grande ricchezza, anche dal punto di vista metodologico:
si tratta della mostra curata da Giovanni Godi e Carlo Sisi, La tempesta
del mio cor. Il gesto del melodramma dalle arti figurative al cinema (Parma,
2001). Non v'è
dubbio che in senso generale le esposizioni teatrali contribuiscano ad
accrescere nel pubblico l'idea che la cultura teatrale, quando si esprime
in opere d'arte o più in generale in manufatti artistici legati
alla pratica spettacolare o anche solo ispirati da essa, tesaurizzi un
patrimonio permanente indipendente dal carattere effimero inevitabilmente
connesso con l'arte stessa del teatro. Dico indipendente da questo senso
dell'effimero e non tanto in contrasto con esso, poiché la valorizzazione
che documenti e "monumenti" del teatro assumono nel quadro di
una esposizione storica li sottrae a quel senso di patetica inferiorità
e a quel che di polveroso e decaduto che sembra pervadere inevitabilmente
le "memorabilia" teatrali anche nella più raffinata delle
collezioni specialistiche. Una consapevolezza più distaccata, e
una lettura scientifica, che vanno significativamente di pari passo con
quel progressivo e purtroppo tutt' altro che completato recupero e restauro
dei nostri edifici teatrali storici, inaugurato in maniera sistematica
nel contesto delle politiche regionali e di molte amministrazioni locali
a partire dall'inizio degli anni '80. |