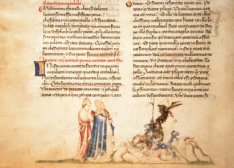"Inspice
lector…". Dal testo all'immagine, dall'immagine al testo: sondaggi
sul rapporto tra parola e figura nel Medioevo e nel Rinascimento,
Università di Pisa, Dipartimento di Storia delle Arti, Dottorato
in Storia delle arti visive e dello spettacolo, 25-26 ottobre 2002
di Chiara
Balbarini
La dimensione
del workshop come momento di incontro tra gli studiosi e occasione soprattutto
per i giovani ricercatori - dottorandi e specializzandi - di confrontarsi
con temi di loro specifico interesse ha trovato negli ultimi anni grande
incremento nell'ambito dei Dottorati di Ricerca dell'Ateneo pisano. Con
particolare assiduità si sono svolti in questo contesto i "Seminari
di Polittico" (dal nome della rivista che raccoglie ricerche scaturite
dalla Scuola di Specializzazione e dal Dottorato in Storia dell'arte),
specificatamente finalizzati a coinvolgere i dottorandi nella discussione
con studiosi provenienti da ambiti disciplinari e accademici diversi.
Scelta stimolante è stata poi quella di lasciare ai dottorandi
stessi l'organizzazione degli ultimi Seminari, invitandoli ad articolare
un percorso ricognitivo attraverso tematiche di comune interesse.
Il tema delle due giornate di studio organizzate insieme a Gerardo de
Simone e Francesca Masi si riallaccia ad illustri e fortunati precedenti
- uno per tutti il convegno cassinense sul Visibile parlare - con l'intento,
peraltro, di mettere a confronto casi e situazioni assai diversi tra loro:
intendendo cioè il rapporto tra testo e immagine nel duplice senso
di testi compresenti all'immagine (codici miniati, tituli, etc.) o ad
essa esterni come fonti (letterarie, agiografiche, documentarie, etc.).
Il titolo, originato dalla visita guidata dal prof. Pinelli alla bella
mostra di Benozzo Gozzoli a Montefalco, cita l'iscrizione presente negli
affreschi eseguiti dal pittore nella chiesa di San Francesco: "[…]
hanc capellam pinsit Benotius […] qualis sit pictor prefatus inspice
lector"; nell'orgogliosa affermazione di autopromozione dell'artista
è implicito il riferimento all'intima e spesso inscindibile connessione
tra il vedere e il leggere che nel Medioevo caratterizza la fruizione
dei manufatti artistici; associazione di parole e figura spesso mutilata,
peraltro, dal tempo e dalla cattiva conservazione delle opere, o - peggio
ancora - travisata dalle vicende del gusto: penso al fenomeno del collezionismo
di cuttings (ovvero miniature ritagliate) che ha fatto scempio di codici
importantissimi, apprezzati più come supporto di pitture in miniatura
che come raffinati organismi dove le immagini sono complementari al testo.
Alcuni problemi teorici di fondo hanno aperto i lavori: quale era l'atteggiamento
degli artisti figurativi nei confronti dell'inserzione nelle loro opere
dell'elemento verbale, e come cambia tale atteggiamento con il trascorrere
dei secoli e con il trasformarsi delle concezioni teoriche sull'arte (in
particolare nel XV secolo, periodo di intensa elaborazione filosofica
e artistica)? Gigetta Dalli Regoli ha evidenziato due polarità
distinte: quella rappresentata dai casi in cui la parola è accolta
all'interno dell'immagine, con essa interagente in armonico equilibrio
- nel Beato Angelico in primis, come ha ben dimostrato l'intervento di
Gerardo de Simone sui perduti affreschi nel chiostro di S. Maria sopra
Minerva a Roma -, e quella in cui la parola è viceversa esclusa
dall'ambito della figurazione anche da artisti grafomani come Leonardo
(si pensi inoltre a Masaccio, Piero della Francesca e Michelangelo). Che
quest'ultima linea divergente nei confronti del passato prossimo medievale
sia stata frutto di un'elaborazione teorica che ha il suo apice nella
definizione della "gofferia" delle scritte inserite nelle pitture
(Vasari 1568) è la proposta aperta della Dalli Regoli che cita
anche altri esempi significativi a riguardo.
A confermare la situazione di equilibrio tra testo e illustrazione che
frequentemente si realizza nei codici medievali è intervenuta Giusi
Zanichelli, la quale ha illustrato la struttura peculiare dei Salteri
glossati: in quelli gallicani, ad esempio, le immagini, definite "conformationes"
da Cassiodoro, servono a stimolare la memoria richiamando la glossa al
testo. All'inverso, ma con un meccanismo del tutto analogo, agiscono le
"laude dipinte" esaminate da Claudio Ciociola, dove i testi
di devozione laicale non di rado sono originati per essere associati all'immagine
(si veda il Cristo in pietà nell'oratorio di Clusone presso Bergamo).
E ancora non molto diverso è il meccanismo che sottintende l'illustrazione
di un commento all'Inferno di Dante degli anni Trenta del XIV secolo -
oggetto del mio intervento - dove la visualizzazione di determinati personaggi
traduce l'interpretazione che il commentatore dà del poema dantesco,
suggerendo inoltre l'universo culturale di riferimento di tale interprete
d'eccezione.
I meccanismi di fruizione dei materiali poetici da parte di un determinato
pubblico - nella fattispecie l'aristocrazia della corte federiciana -
possono essere esplicitati dai documenti figurativi, come ha evidenziato
la relazione di Maria Luisa Meneghetti, dedicata ad un affresco cortese
recentemente scoperto a Bassano.
Che le immagini possano essere lette fungendo da sostituto della parola
scritta, a patto che i lettori-spettatori siano in possesso di codici
di riferimento culturale largamente condivisi, è ben dimostrato
da un passo del Filocolo di Boccaccio sul quale ha richiamato l'attenzione
Lucia Battaglia Ricci.
Sul rapporto tra i letterati e le arti figurative è tornata Valentina
Brancone in un'approfondita indagine riguardante il giudizio di Petrarca
sulla mimesis artistica e il suo probabile ruolo di ispiratore della Sala
dei Giganti nella Reggia Carrarese di Padova; Sonia Cavicchioli si è
invece occupata della fortuna di Apuleio e della favola di Psiche nell'arte
del Quattro e Cinquecento, mentre Vincenzo Farinella ha richiamato l'attenzione
su una favola classica che ebbe grande fortuna popolare nel Medioevo,
quella di Virgilio vittima dell'amore, utilizzata con risvolti autobiografici
da Urs Graf.
Non poteva mancare infine il ricordo - tracciato da Ciociola - di chi
è stato senza alcun dubbio un pioniere di questi studi, cioè
Padre Giovanni Pozzi, venuto a mancare fatalmente proprio nei giorni in
cui era in preparazione il Seminario. L'acume interpretativo dispiegato
entro un'area di interdisciplinarietà che abbraccia la letteratura
quanto la teologia e la storia dell'arte rimane esempio insuperato per
le giovani generazioni di studiosi di un corretto approccio ai complessi
problemi oggetto del Seminario pisano.
|