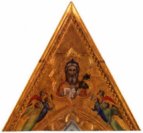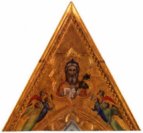|
MATTEO DA GUALDO. Rinascimento eccentrico tra umbria e marche
Gualdo Tadino, Museo Civico Rocca Flea, 21 marzo-27 giugno 2004, mostra
e catalogo a cura di Eleonora Bairati e Patrizia Dragoni;
convegno di studi, Gualdo Tadino, 21-22 maggio 2004.
di Gerardo
de Simone
Con l'unità
d'Italia, il ritrovato orgoglio civico delle mille "piccole patrie"
disseminate lungo la penisola ha prodotto la celebrazione delle glorie
artistiche locali, spesso risollevate da un plurisecolare oblio, come
a Lucca Matteo Civitali e a Gualdo Tadino Matteo di Pietro, entrambi omaggiati
quest'anno da due importanti rassegne monografiche nelle rispettive città.
A Gualdo la mostra è stata integrata da un convegno, svoltosi il
21 e 22 maggio, che ha affrontato non solo il singolo pittore Matteo e
la sua bottega familiare, ma la rete delle relazioni e degli scambi nell'area
umbro-marchigiana, interessata nel Quattrocento da un fertilissima fioritura
di artefici: da un lato tenacemente e splendidamente interpreti della
tarda fiammata del gotico; dall'altro aperti, ora più superficialmente,
ora più in profondità, alle novità prospettiche rinascimentali.
La sigla del 'Rinascimento eccentrico', scelta come efficace epigrafe
tanto della mostra quanto del convegno, affonda le sue radici nelle indovinate
formule del "Rinascimento umbratile" di Roberto Longhi (1926)
e dello "Pseudo-Rinascimento" di Federico Zeri (1983), che hanno
contribuito in modo decisivo alla riscoperta e all'apprezzamento dei cosiddetti
'eccentrici'.
In apertura Bruno Toscano ha messo in guardia dalle riletture attualizzanti
e dalle conseguenti, troppo disinvolte applicazioni lessicali (irrealismo,
metafisica, espressionismo) ad artisti e correnti che occorre invece contestualizzare,
ricercando nell'epoca e nei luoghi di pertinenza, nel clima storico, culturale,
religioso e sociopolitico in cui operarono le ragioni degli indirizzi
adottati. Anzi, a valutare la diffusione degli 'eccentrici', c'è
da chiedersi se non sia piuttosto il Rinascimento ad essere 'eccentrico',
quantitativamente e geograficamente minoritario. Nello specifico umbro-marchigiano,
è da osservare la svolta piuttosto netta che si verifica intorno
alla metà del secolo, da una società cortese, di signorie
(come i Trinci a Foligno o i da Varano a Camerino), nella quale prevale
il linguaggio 'internazionale' e gli artisti sono 'vaganti', ad una società
caratterizzata dalla rivincita della Chiesa e del sacro, dove gli artisti
sono prevalentemente stanziali e si differenziano in una miriade di parlate
'locali'.
Tipico esempio di artista stanziale è Matteo da Gualdo (1430/35-1507),
il cui raggio d'azione non si estese mai oltre Assisi o Nocera Umbra (ad
eccezione del Trittico di Coldellanoce per le vicine Marche), e la cui
bottega impiantò un solido monopolio nel gualdese, destinato a
durare col figlio Girolamo e il nipote Bernardo. All'importanza delle
fonti archivistiche per la ricostruzione delle vicende di Matteo e della
sua famiglia si è dedicato l'intervento di Sonia Merli, che ha
sottolineato l'utilità di una fonte come i testamenti (Matteo ne
redasse ben cinque tra il 1465 e il 1505). Un profilo biografico-critico
di Matteo, Girolamo e Bernardo è stato tracciato da Enzo Storelli,
erudito gualdese, che ha riletto Matteo, già riconosciuto da Zeri
come principale erede di Bartolomeo di Tommaso da Foligno, alla luce della
pluralità di contatti - centroitaliani, meridionali, nordici -
ravvisabili nel suo corpus, ivi compreso il fondamentale apporto senese
(Giovanni di Paolo su tutti); così come di Girolamo e Bernardo,
notai oltre che pittori, ha evidenziato la pur timida apertura a influssi
perugineschi e signorelliani.
Nei primi anni del Novecento una serie di mostre, in Italia come in Europa,
consacra la riscoperta, condita di orgoglio nazionalistico-municipalistico,
dei 'primitivi' e delle scuole locali (Bruges nel 1902, Parigi nel 1904,
Siena e Macerata nel 1905, Perugia nel 1907): alla mostra perugina venne
esposto, nella sala dedicata a Matteo, il Trittico di S. Pietro a Gualdo,
che fu però riconosciuto come falso: fortunatamente l'originale
(smerciato anni prima con la complicità dell'abate di S. Pietro)
venne poi ritrovato presso un antiquario romano e riconsegnato alla sede
originaria nel 1912. Tale episodio, emblematico delle difficoltà
della tutela del patrimonio artistico negli anni di passaggio dalla volontaristica
tutela locale a quella centralizzata, regolata dalla legge del 1902-9,
è stato rievocato da Eleonora Bairati. Federico Valacchi ha confermato,
in relazione alla situazione archivistica, la svolta dal modello gestionale
policentrico all'indomani dell'Unità (si veda la relazione di Cesare
Guasti nel 1870) a quello accentrato invalso fino al 1939, con la successiva,
graduale valorizzazione delle risorse locali, che ha prodotto ottimi risultati
in Umbria, mentre forti ritardi e manchevolezze permangono in altri ambiti
regionali.
Il panorama artistico coevo a Matteo è stato illuminato in varie
direzioni dagli altri interventi. Giordana Benazzi ha presentato il milieu
folignate, nell'imminenza dell'inaugurazione della mostra dedicata
a Niccolò Alunno (Nicolaus pictor. Artisti e botteghe a Foligno
nel Quattrocento, 29 maggio-3 ottobre), di cui sono state fornite
alcune anticipazioni. Quanto poco le periferie fossero isolate e quanto
invece fossero crocevia di relazioni transprovinciali è esemplificato
da due documentate èquipes: Gentile da Fabriano, Jacopo
"da Vinegia", Giambono da Budrio, Battista da Padova e Paolo
Nocchi da Foligno a Palazzo Trinci nel 1411-12; Bartolomeo di Tommaso,
Nicola da Siena, Andrea Delitio, Giacomo di Corrado da Ragusa e Luca di
Lorenzo d'Alemagna in S. Agostino a Norcia nel 1441-42.
Elvio Lunghi ha toccato il delicato tasto dell'allievo di Perugino Andrea
d'Assisi, la cui opera risulta difficilmente ricostruibile con certezza
per le scarse informazioni documentarie e le non pacifiche distinzioni
di mano rispetto al maestro e soprattutto al coetaneo Pinturicchio. Uno
squarcio è stato abbozzato sulla giovinezza del Perugino, su una
prima formazione cioè umbra e preverrocchiesca, ipotesi finora
poco sondata dalla critica e che può essere rilanciata alla luce
della grande mostra perugina di quest'anno (Perugino il divin pittore,
27 febbraio-5 settembre). Di Pinturicchio è stato notato il legame
con la committenza Baglioni, più stretto e duraturo di quello avuto
da Perugino, esemplificato da una doppia commissione a Spello, a distanza
di alcuni decenni, la prima per Braccio, la seconda per Troilo.
Fabio Marcelli ha esaminato i resti di affreschi dell'ex chiesa di S.
Margherita a Cascia, proponendone l'attribuzione a Saturnino Gatti, pittore
e scultore aquilano, allievo di Silvestro dell'Aquila. Il confronto delle
pitture di S. Margherita con il ciclo di S. Panfilo a Tornimparte (AQ),
datato al 1494 c., e il documentato impegno di Saturnino negli stessi
anni in S. Maria della Pieve a Norcia (affreschi perduti) fornirebbero
un plausibile appiglio cronologico per il ciclo di S. Margherita, contribuendo
all'auspicabile ricostruzione dell'attività umbra del Gatti, lungo
il triangolo Cascia-Norcia-L'Aquila.
Tre giovani studiosi dell'Università di Macerata, Sabina Biocco,
Francesca Coltrinari e Giuseppe Capriotti, hanno illustrato i risultati
delle proprie ricerche di dottorato. Le prime due dando notizia di una
cospicua serie di ritrovamenti documentari, vertenti nell'un caso sulle
presenze di artisti umbri nelle Marche (il perugino Anselmo di Giovanni,
a Jesi, Sassoferrato, Matelica; il suo allievo Orlando Merlini, a Macerata
Feltria e Albacina; il figlio di Bartolomeo di Tommaso, Polidoro, a Sassoferrato;
un altro perugino, Sebastiano di Rodolfo della Pietra, pure a Sassoferrato
e ad Arcevia), nell'altro sull'intagliatore Paolino da Ascoli e la sua
bottega tra Umbria e Marche (attivo tra il 1448 e il 1456 tra Assisi e
Perugia, nel decennio 1456-67 a Tolentino; suoi soci di volta in volta
Apollonio di Ripatransone, Giovanni di Stefano di Montelparo, Diotisalvi
da S. Ginesio, Tommaso di Antonio da Firenze e il dalmata Giovanni Schiavo).
Capriotti ha indagato invece l'iconografia di S. Sebastiano nella scultura
lignea umbro-marchigiana, soffermandosi in particolare sulla soluzione
con un braccio sollevato, attestata in alcuni dipinti fiamminghi e incisioni
nordiche (si ricordi la presenza dei protostampatori tedeschi a Foligno
e di due Crocifissi lignei di Johannes Teutonicus), adottata ad esempio
da Domenico Indivini.
Gabriele Barucca ha ripercorso la storia e i restauri delle tavole di
Niccolò Alunno per S. Maria in Piazza a Sarnano (i due pannelli
con i SS. Pietro e Giovanni Battista e i SS. Benedetto e Biagio); Maria
Stella Spampinato e Barbara Provinciali hanno fatto altrettanto con il
Polittico di Recanati di Ludovico Urbani.
Fuori programma un breve intervento di Matteo Mazzalupi, che ha mostrato
un ciclo di affreschi, pressoché inedito, in S. Maria di Laverino
a Fiuminata, datato 1506 e attribuibile alla mano di Girolamo di Matteo
da Gualdo.
In chiusura Massimo Ferretti, nel giudicare positivamente l'equilibrio
tra profilo monografico e contestualizzazione storico-geografica emerso
nel convegno, ha ribadito l'importanza della riscoperta ottocentesca di
Matteo, culminata nella dedicazione al pittore del Museo Civico di Gualdo.

Matteo da
Gualdo, Madonna in trono col Bambino, i santi Lorenzo e Sebastiano e il
committente inginocchiato, 1480-90 c., Coldellanoce (Sassoferrato), S.
Lorenzo
Torna all'inizio
|