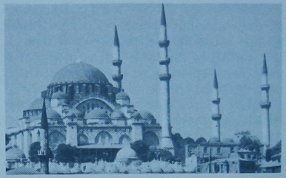Magnificenza
del Quattrocento in mostra a Parigi
di Chiara Balbarini
La serie di mostre sul Quattrocento che si è inaugurata a Parigi
alla fine di febbraio con la retrospettiva sui "Primitivi" francesi,
e che terminerà a Chantilly il 2 agosto quando il codice delle
Très riches heures tornerà negli scaffali dell'antico
Cabinet des livres del duca d'Aumale, ha portato un fondamentale
contributo alla conoscenza della produzione artistica francese di un periodo
spesso riduttivamente associato ai drammatici eventi della guerra dei
Cent'anni.
L'esposizione del Louvre Primitifs français. Découvertes
et redécouvertes traccia un bilancio degli studi a un secolo
dalla grande mostra-evento del 1904: un atto dovuto in un certo senso
- per dirla con i curatori - verso le nuove acquisizioni di quel "piccolo
mondo degli specialisti" sempre impegnato ad incrementare la conoscenza
delle scuole pittoriche francesi e dei loro rapporti con le altre scuole
"europee". È questa anche l'occasione di chiarire questioni
controverse, come l'identificazione dei numerosi artisti attivi nell'illustrazione
libraria parigina degli anni Cinquanta-Settanta, indagata recentemente,
con argomenti convincenti, da François Avril e Nicole Reynaud.
Restituire un'epoca e una città nella complessità degli
aspetti politici, culturali, economici, attraverso lo "specchio"
dei manufatti artistici - siano essi cattedrali, preziosi oggetti di oreficeria
o codici miniati - è stato lo scopo che si è prefissa la
mostra aperta anch'essa al Louvre in marzo, da poco conclusa. Paris
1400. Les arts sous Charles VI ha avuto non soltanto il merito di
esporre al grande pubblico una moltitudine di oggetti raffinatissimi,
realizzati nelle tecniche più disparate: tessili straordinari come
il Paramento di Narbonne o la mitria ricamata della Sainte Chapelle; dipinti
di devozione privata come la serie delle Pietà ronde; libri
d'ore, bibbie e testi letterari miniati per i più importanti personaggi
politici del momento: Jean de Berry, Philippe le Hardi, il maréchal
Boucicaut e molti altri.
Far rivivere, almeno per il tempo dell'evento, la straordinaria fioritura
artistica che Parigi conobbe al tempo di Carlo VI è dunque il sogno
realizzato del direttore del Musée du Louvre, Henri Loyrette e
della curatrice della mostra, Elisabeth Taburet-Delaye, dimostrando le
potenzialità che una mostra d'arte offre quando si sappiano sfruttare
al meglio.
Premessa a questa dettagliata ricostruzione storica, lo scardinamento
di luoghi comuni e preconcetti, primo tra tutti la generale "cattiva
reputazione" del regno di Carlo VI, passato alla storia, appunto,
come "Carlo il folle". Se infatti occorre tener presente che
alla morte del padre Carlo V, nel 1380, l'attività artistica non
subì alcuna rottura nella capitale e gli zii del giovane Carlo
VI, incaricati del regno in sua vece, si rivolsero agli artisti già
utilizzati dal fratello, non bisogna d'altra parte dimenticare che la
crisi politica e i disastri militari culminati nella battaglia di Azincourt
iniziarono soltanto nel secondo decennio del Quattrocento, dopo anni di
intensa produttività e originali risultati, che mal si riducono
nella semplice formula di "arte di corte" o "Gotico internazionale".
In effetti a tutto vien da pensare ammirando la mostra del Louvre meno
che a crisi politiche e sconfitte militari. È soprattutto la perizia
tecnica degli artefici che stupisce il visitatore; stupisce ancor di più
se si pensa alla rapidità con cui essi dovevano soddisfare la domanda
continua della corte: oggetti destinati a chiese come doni a Dio, alla
Vergine, ai santi protettori del regno, o doni diplomatici realizzati
in occasione di incoronazioni, matrimoni e altre sfarzose feste d'apparato.
Basti l'opera emblema della mostra, che sembra appena uscita da un laboratorio
di Fabergé tanto risplende di perfezione esecutiva, doratura, smalti,
pietre preziose e perle in profusione: è il cosiddetto Cheval
d'or, dono della regina Isabella al re suo sposo in occasione del
nuovo anno (1405). Interessante anche dal punto di vista più ampio
della storia di questo tipo di manufatti: l'opera, che riunisce nella
rappresentazione il mondo temporale della corte - in cui figura il ritratto
dello stesso Carlo VI - e il mondo celeste, divenne solo più tardi
un reliquiario; fu concepito cioè con finalità esclusivamente
estetiche e "politiche", gioiello teso ad esaltare l'autorità
del re, nel suo rapporto diretto con la Vergine.
La mostra, e il relativo, approfondito catalogo, hanno il merito di analizzare
nelle varie sezioni le grandi tematiche che consentono di capire meglio
la mentalità del tempo: come il cosiddetto preumanesimo parigino,
che vide un'intensa attività di traduzione e di rifacimento di
classici (Sallustio, Cicerone, Livio, Terenzio, testimoniati da splendidi
codici illustrati); insieme alla produzione di "libri di saggezza"
per il principe, frutto di riflessioni e dibattiti letterari, animati
da Christine de Pizan e Jacques Legrand.
Il libro figurato come veicolo di messaggi politici, manifesto di una
ben precisa idea del regno e del suo rapporto con l'autorità spirituale,
è il tema che emerge anche nella piccola mostra di Chantilly: Les
Très Riches Heures du duc de Berry et l'enluminure en France au
début du Xve siècle (Musée Condé). Il
famoso codice illustrato dai fratelli Limbourg - presente in originale,
e offerto nella sua interezza alla fruizione del visitatore grazie ad
un CDrom - è affiancato da libri come Les histoires de Bertrand
du Guesclin, difensore del regno di Carlo V, e la Mutacion de Fortune
di Christine de Pizan, autore-imprenditore delle proprie opere, emblematica
figura della modernità.
|
|
| Sinan,
l'architetto di Solimano il Magnifico
di Claudia
Massi
Nato
in Anatolia, nella regione di Kaiseri, in provincia di Karaman, Sinan
(1491-1588) giunse in giovane età a Istanbul, dove divenne prima
un devsirme (alla lettera un "accolto"), poi un giannizzero,
essendo entrato nella fanteria dell'esercito imperiale, così come
si legge su Cose notevoli dell'architettura, scritto dal poeta Mustafa
Sa'i Çelebi, contemporaneo di Sinan stesso.
I devsirme, ragazzi d'età compresa tra gli otto e i diciotto
anni, generalmente orfani o provenienti da famiglie disagiate, non necessariamente
musulmane, venivano prescelti in base a particolari attitudini, da un'apposita
commissione inviata dal sultano nelle diverse regioni dell'impero. Nella
capitale, per accedere alla compagnia dei cadetti, studiavano la lingua
turca, la religione e la tradizione ottomana; successivamente venivano
istruiti per essere ammessi al corpo dei giannizzeri. Chiunque poteva
intraprendere la carriera militare o entrare a far parte dell'apparato
imperiale, in una società, come quella ottomana del XVI secolo,
che era una teocrazia di tipo militare. In questo periodo di massimo accentramento
del potere nelle mani di Solimano, l'impero fu investito da una radicale
modernizzazione, soprattutto dovuta all'intensa attività legislativa
promossa dal sultano, uomo poliglotta e di grande cultura, che perseguiva
un progetto mirato all'unione dei territori orientali con quelli occidentali.
All'espansione dei confini corrispose la nascita di una "magnifica"
corte, nota in tutta Europa, per cui a Solimano fu attribuito il titolo
omonimo.
Sinan aveva iniziato la sua carriera militare con Selim I, padre di Solimano,
e aveva partecipato, in veste di soldato, a diverse imprese belliche,
continuate da Solimano medesimo, ossia le campagne di Belgrado (1521),
di Rodi (1522), di Corfù (1537) e di Moldavia (1538), per citarne
alcune. Fu così che dal secondo decennio del Cinquecento Sinan
divenne un abile costruttore, attraverso un'esperienza fatta sul campo,
grazie alla conoscenza diretta dei più importanti monumenti antichi,
asiatici ed europei, e grazie alla pratica acquisita proprio dalle operazioni
belliche, che richiedevano lavori di carpenteria e di cantieristica navale,
a cui si applicò assiduamente.
Insieme all'apprendistato come carpentiere, la sua attività fu
indirizzata verso la progettazione edilizia. Nel 1521 Solimano gli affidò
l'incarico di realizzare una moschea e una tomba in onore del padre, morto
l'anno precedente. A questo primo lavoro ne seguirono altri, non ancora
importanti da renderlo celebre, ma comunque indispensabili per la sua
formazione, come gli edifici a copertura lignea.
Per la progettazione di monumenti a cupola di muratura furono fondamentali
per Sinan gli studi intrapresi a Istanbul, attraverso i quali giunse a
una approfondita e diretta conoscenza di opere come la chiesa di Santa
Sofia (532-537), la chiesa di S. Sergio e Bacco (527-536), la moschea
di Fatih (1462-1470) e la moschea di Beyazid II (1501). In particolar
modo si soffermò ad analizzare, da un punto di vista strutturale,
la grande cupola di Santa Sofia, a cui farà riferimento costantemente
nelle realizzazioni della sua maturità, fra le quali vanno ricordate
la moschea di Sehzade (1543-1547) e la moschea di Solimano (1550-1557)
a Istanbul, la moschea di Selim II (1568-1573) a Edirne.
Nel 1539 Sinan fu nominato architetto-capo dell'impero e ministro dei
lavori pubblici, con compiti che andavano dalla costruzione di complessi
religiosi alla sistemazione di strade e ponti, dalla supervisione delle
reti idriche alla scelta dei materiali edilizi e al controllo sull'applicazione
delle norme relative alle costruzioni.
Tutti i lavori compiuti da Sinan durante la sua lunga vita sono riferiti
in tre manoscritti, "Tezkiretü'l Bünyan", "Tezkiretü'l
Ebniye" e "Tuhfetü'l mi'marin", redatti tra il 1580
e il 1590 da Mustafa Sa'i Çelebi. Il catalogo completo dell'architetto
comprende, entro i confini ottomani, 477 opere, tra moschee, tombe, caravanserragli,
scuole coraniche, bagni turchi, ospedali, palazzi, ponti, acquedotti etc.
Di queste, 328 si trovavano vicino alla capitale, 75 erano in Anatolia,
Siria e Iraq, 44 in Romania, in Crimea e nei Balcani. Secondo un'indagine
di A. Kuran, riportata in "Sinan. The Grand Old Master of Ottoman
Architecture" (1987), sul totale delle realizzazioni, 31 non sono
oggi identificabili, 173 sono state distrutte dagli incendi o dai terremoti,
52 non hanno più la loro originaria struttura in seguito a interventi
di trasformazione, 25 sono in stato di completo abbandono e solo 196 hanno
mantenuto la stessa tipologia architettonica.
Per seguire i lavori quale architetto-capo, Sinan aveva raccolto intorno
a sé una quarantina di persone, tra architetti e capomastri, in
grado di operare con efficienza in qualsiasi parte dell'impero. Certamente
le costruzioni realizzate fuori dalla capitale, che non erano supervisionate
direttamente dal maestro, apparivano stilisticamente meno compiute. Pur
disponendo sul posto di disegni preparatori o di modelli, molte volte
le maestranze del luogo non riuscivano a comprendere nel dettaglio il
progetto di Sinan e la lontananza dell'architetto si rifletteva così
sugli esiti dei lavori, sia dal punto di vista strutturale sia da quello
stilistico.
Una delle opere più importanti di Sinan è senza dubbio il
complesso di Solimano il Magnifico, realizzato tra il 1550 e il 1557.
La moschea e gli edifici annessi, cioè i bagni pubblici, le scuole,
l'ospedale, l'ospizio per i poveri, il mausoleo, collocati sulla sommità
del terzo dei sette colli di Istanbul, degradano verso il Corno d'Oro.
I fabbricati disposti intorno alla moschea sono caratterizzati dalla presenza
di cortili, giardini, portici coperti a cupola, spazi raccolti, che ben
si prestano per la preghiera. Nelle intenzioni di Sinan la moschea doveva
superare, per magnificenza, la chiesa di Santa Sofia, per dimostrare al
mondo di "essere più bravo dei bizantini" nella realizzazione
di un edificio di culto.
|
|