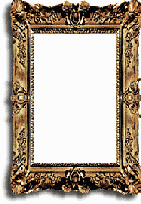
|
|
||||||||||||
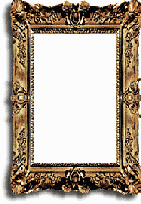 |
||||||||||||
|
Cornice
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ITALIA S.p.A./Tarlo di Gerardo de Simone Approvata finalmente la legge Cirami, sarà lecito auspicare l'estensione del "legittimo sospetto" dalle aule dei tribunali ai palazzi ministeriali e agli uffici governativi, non solo a chi giudica, cioè, ma a chi legifera? A leggere Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale, di Salvatore Settis (Torino, Einaudi, 2002, euro 8,80) non c'è che da augurarselo. La Patrimonio S.p.A. (L. 112/2002), che "monetizza" il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico italiano in vista di una sua possibile alienazione - d'intesa con la sua "gemella", la Infrastrutture S.p.A., che la definisce nei termini ulteriori di concreta privatizzazione - desta infatti ben più di un "legittimo sospetto": l'intero patrimonio dei beni culturali (e ambientali) italiani diventa possibile oggetto di vendita, cessa di essere vincolato a quelle rigide norme di tutela e di salvaguardia, configurate dalla legge 1089 del 1939 (peggiorata, ma non alterata nei principî di fondo, dal cosiddetto Testo Unico del 1999), che finora ne avevano garantito, almeno sulla carta, la protezione. Il processo di "svendita" del nostro patrimonio, nell'impeccabile ricostruzione di Settis, non è un fatto di destra o di sinistra, ma tristemente si svolge lungo una linea di continuità dai governi dell'Ulivo a quello attuale di centrodestra: Urbani e Tremonti non hanno fatto che portare alle estreme conseguenze quanto già avviato da Veltroni e Melandri. Le premesse della doppia tendenza a privatizzare e decentrare l'amministrazione dei beni culturali, seguendo l'assioma imperante quanto nefasto della separazione tra gestione e tutela, affondano da un lato nell'immobilismo dell'apparato ministeriale, paralizzato da una burocrazia lenta e da una perenne scarsezza di fondi; dall'altro nell'elezione a paradigma di riferimento, a fronte di una supposta, ma data per certa, arretratezza italiana, di modelli stranieri, in particolare di quello americano. Ma la cultura italiana della tutela del patrimonio è in realtà storicamente la più ricca e avanzata, eredità dell'identità culturale e nazionale formatasi all'indomani dell'Italia unita, e prima ancora delle legislazioni protezionistiche "moderne" degli stati preunitari, grazie alle quali tanto del nostro patrimonio si è preservato (fin dai vincoli imposti da appositi "uffiziali dell'ornato" nella Siena o nella Verona del Duecento). E il modello americano, che Settis conosce da vicino, avendo diretto per cinque anni il Getty Institute in California, risulta semplicemente inapplicabile alla realtà italiana, in quanto: a. si fonda su capitali iniziali da noi inimmaginabili, al cui investimento affida la produzione degli utili, e tramite questi copre le spese di gestione (solo in minima parte ammortizzabili dai "servizi" accessori come bookshop, caffè, ristoranti ecc.); b. non nasce da quel legame diretto, ramificato e privilegiato con il territorio che costituisce la ricchezza e l'unicità dei musei italiani. Proprio la valorizzazione del "tessuto connettivo" che lega in un insieme inscindibile musei e monumenti, città e contado - seguendo la lezione pionieristica e quanto mai attuale di Quatremère de Quincy e Canova -, dovrebbe essere al centro dei progetti di riforma; in direzione opposta, secondo Settis, va la costituzione in soprintendenze autonome (a Roma, Napoli, Firenze e Venezia) dei "poli museali", resi avulsi dal contesto in cui sono inseriti; mentre confusione e imbarazzo finora ha suscitato la creazione dei Soprintendenti Regionali. La coscienza responsabile del patrimonio dovrebbe esaltare, non deprimere, la trama dei rapporti che compongono la complessa, stratificata identità storico-culturale italiana: in tal senso andrebbe riallacciato l'intreccio tra musei e soprintendenze da un lato, università e scuola dall'altro, tra tutela/conservazione e ricerca/formazione, reciso alla base fin dall'istituzione autonoma del Ministero dei Beni Culturali, nel 1974 (certo non nelle intenzioni del suo artefice, Spadolini). Emblematica delle conseguenze negative di tale separazione è l'attuale situazione di stallo dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Palazzo Venezia, fondato da Adolfo Venturi. D'altronde Settis è ben cosciente delle necessità di riforma. Lo stato italiano è proprietario di un'enorme quantità di beni immobili, spesso fatiscenti, o utilizzati solo in parte, o inappropriatamente. Ma saper mettere a frutto le potenzialità di questo patrimonio richiede innanzitutto una rigida distinzione, tra beni alienabili (in tutto o in parte) e inalienabili, a seconda che abbiano o meno un interesse storico o artistico. Con la legge Tremonti tale distinzione, finora vigente - e vincolante - scompare: tutti i beni, sia demaniali che patrimoniali, sono sulla carta svendibili; anche se, come Urbani e Tremonti si ostinano a ripetere, nessuno potrà mai comprare il Colosseo, "la legge lo consente pari pari, e anche i pazzi possono salire a posizioni di comando" (Andrea Emiliani) - senza dire che il vero problema non sono le emergenze isolate, i monumenti più noti, ma il "museo diffuso", il patrimonio disseminato sul territorio, quello più esposto e indifeso. Dietro l'angolo poi si aggira il fantasma del "cambio della destinazione d'uso", che può riguardare beni anche di valore artistico o ambientale, di proprietà sia pubblica che privata (lo ha sottolineato la trasmissione di Rai Tre Report il 22/11/2002). "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione": l'art. 9 della Costituzione italiana sintetizza il principio ispiratore della battaglia culturale e civile che anima le pagine di Settis. Battaglia che ha chiamato, e chiama, a raccolta in questi mesi migliaia di cittadini preoccupati delle possibili conseguenze della Patrimonio S.p.A. Un appello con oltre duemila firmatari è stato redatto dai docenti universitari Donata Levi e Marco Collareta, trovando consensi tra archeologi, storici dell'arte, responsabili delle soprintendenze, esponenti di associazioni come il FAI, Italia Nostra, l'Unesco. L'iniziativa prosegue sul sito www.patrimoniosos.it. Intanto, mentre critiche alla legge arrivano anche da ambienti di centrodestra, è stata appena insediata la commissione che dovrà predisporre il tanto atteso, e fin qui rinviato, Codice dei Beni Culturali: di essa fanno parte fior di giuristi, ma vi si cercherà invano il nome di un archeologo, di un restauratore, di uno storico dell'arte (la lista si può consultare sul sito del Ministero, www.beniculturali.it). È forse giunto il momento in cui gli "addetti ai lavori" facciano sentire la propria voce, reclamando il posto che gli spetta e che gli compete, là dove è in gioco una fetta così importante dell'identità e del patrimonio del Paese. |
|
|
||
|
La
copertina del libro di Settis
|