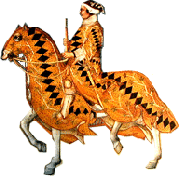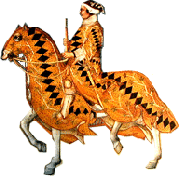|
Ad limina mundi: la linea d'ombra su un
lembo di Toscana
di Emanuele Pellegrini
Con una felice intuizione il Sismondi battezzò
col nome di "Svizzera pesciatina" quella porzione di montagne
che si apre a nord di Pescia, la piccola città ove lo storico ginevrino
risiedette e lavorò per alcuni anni, regalandole poi il suo archivio.
In questo territorio, ormai quasi dimenticato dagli uomini, si nascondono
dieci piccoli borghi, o castella come di solito venivano chiamati.
Si tratta di comunità ormai quasi disabitate ma dalla storia millenaria,
resa ancora eloquente dagli affascinanti nomi che i secoli, dopo infiniti
precipitati, ci ha consegnato così: Vellano, Sorana, Aramo, San
Quirico, Stiappa, Castelvecchio, Pontito, Pietrabuona, Medicina e Fibbialla.
Questi paesi, pazientemente studiati dall'infaticabile Emanuele Repetti
- il primo che li abbia catalogati tutti - si distendono in una sorta
di ellisse che ha per estremi Pietrabuona a sud e Pontito a nord, toccando
un intreccio di tre valli - Valleriana, Val di Torbola e Val di Forfora
- cui la Storia ha depositato sopra a sua volta il concettoso incastro
dei confini della diocesi di Lucca con quelli della Pesciatina, del comune
di Pescia, della provincia di Pistoia e delle competenze della Soprintendenza
di Firenze.
Non è poi affare complicato, per il viaggiatore incantato, svelare
per verba le ricchezze di tale territorio, geografiche e storiche: le
prime di per se stesse eloquenti, con la statale di cemento - sovrapposta
ai tratturi su cui si sono mossi i secoli - ombrata da castagni immensi
che regalano un silenzio profondo; le seconde meno note, come accade a
tutta questa parte di mondo, tanto che sembra opportuno ricordare Coluccio
Salutati che nel 1367 scrive gli statuti del comune di Vellano, l'opera
di Francesco di Valdambrino come sgocciolata sul territorio, in un dripping
le cui trame sono ancora da ricostruire, qualche lacerto di freschi giotteschi
(col beneficio della paternità nobilitante), trittici a fondo oro
inevitabilmente rubati, madonne in terracotta tardo-quattrocentesche e
pittori di buona fama a segnalare che anche il Cinquecento, il Seicento,
il Settecento e l'Ottocento - incredibile dictu - sono passati
di qua. Attenzione, non per pennelli o scalpelli locali, ma scomodando
anche personaggi spagnoli o napoletani. Aggiungere che Lazzaro Papi, gloriato
del monumento lucchese, era nato a Pontito, e che Domenico Moreni vide
la luce a Castelvecchio, appare superfluo e forse ingiusto, quasi si volesse
puntare il dito su coloro che abbandonarono a se stessa la terra natia.
E il Novecento? Sedetevi a tavola: difficile rispondere a questa domanda
e ricostruire il quadro esatto di un millennio di storia che sbocca nel
secolo breve, ancora più breve in questi dieci castelli, senza
una meditazione culinaria che può avvicinare molto alla piena comprensione
del tutto; e vada per la carne di cinghiale e selvaggina varia, i funghi
porcini e le castagne, alimento primo della zona, e dalla loro farina
i caratteristici necci, che si ottengono impastando la farina con acqua
e cuocendola poi in piastre di pietra racchiuse nelle foglie del castagno.
Il Novecento, dicevo. È passato di qua con qualche ricordo ai caduti
della prima guerra mondiale e poi con le targhe in pietra delle stragi
nazifasciste. È passato di qua con le casse della collezione di
Lamberto Vitali, custodite e nascoste dal solerte Carlo Magnani, allora
direttore della Biblioteca e del Museo Civico di Pescia. Ma è passato
di qua, soprattutto, regalandoci un museo che può essere eletto
a simbolo della zona intera: il Museo della Carta. Il Museo della Carta
è l'epigono e la consacrazione di un alacre attività di
cartai e cartiere che ha arricchito e caratterizzato la montagna pesciatina
per secoli. Coi Turini prima (del 1481 la loro cartiera), passando per
l'esperienza della stamperia Cenni-Orlandi, impiantata al precocissimo
anno 1485 e inaugurata con la pubblicazione delle opere di Bernardino
da Siena e poi del Savonarola, si sarebbe giunti alle famiglie provenienti
dalla riviera ligure, gli Ansaldi ed i Magnani, le quali, soprattutto
tra Settecento ed Ottocento, avrebbero accresciuto e migliorato gli "edifizi
da carta", perfezionando la preziosa tecnica che porta dalla macerazione
degli stracci alla creazione del foglio. L'acqua del fiume Pescia, che
attraversa la montagna per arenarsi poi nell'Arno, costituisce l'elemento
primo di una così straordinaria pratica artigiana, cui si associano
tecniche contadine trasferite a questo mondo preindustriale: ruote di
mulino, tini, strizzi, macine per olivi.
Il Museo della Carta, in realtà, vive nel Centro di Documentazione
sulla Lavorazione della Carta situato a Pietrabuona, una struttura patrocinata
dall'Associazione Cartai, nella quale, attraverso modellini di macchinari
riprodotti in scala e mezzi audiovisivi, viene illustrata la fabbricazione
manuale della carta, i fogli di diversa grammatura, le filigrane, i timbri.
Ma il museo, quello vero, in realtà è un po' l'incarnazione
dell'oggi tanto discusso ed agognato museo diffuso: infatti, esso consiste
e vive propriamente nelle antiche cartiere, enormi pachidermi nascosti
da queste montagne. Attualmente è possibile visitare l'edificio
chiamato Le Carte, il gioiello forse più prezioso, ubicato a Pietrabuona,
a pochi metri dal Centro di Documentazione. Una cartiera enorme e nobile,
in cui Napoleone volle venissero prodotti gli inviti per le sue nozze
con Maria arciduchessa d'Austria, di cui si conserva ancora la "forma"
ed esempi di fogli con le due auguste effigi. Un momento altissimo di
una energia produttiva e creatrice che è evaporata negli anni sessanta-settanta
del Novecento, portandosi dietro lo spopolamento dell'intera zona. Il
museo, da circa un anno regolarmente aperto le mattine di martedì,
giovedì e sabato, può ora riscattarla e riqualificarla,
recuperando, attraverso la testimonianza storica, un complesso di tradizioni,
splendori ed anche miserie. Artigiane, ci mancherebbe.
Rimangono nei ricordi di queste terre e delle loro cartiere, la figura
agitata di Lorenzo Viani, che veniva ad acquistare la carta alla cartiera
Magnani, povero e sempre senza soldi, tanto che, per sdebitarsi dei fogli
che gli venivano spesso regalati, ideò ed incise il simbolo della
medesima cartiera Magnani, con i suoi ingranaggi in movimento bloccati
da un segno spesso e violento. Oppure, dopo di lui, De Chirico e Guttuso,
ancora ben vivi nella mente di Angiolino Vezzani, maestro cartaio di eccellente
bravura, il quale - sigaretta tra le mani nodose, spirito arguto di inossidabile
e profonda intelligenza - ben volentieri racconta di questi artisti con
cui ebbe a lungo a che fare, delle loro richieste e del suo impegno nel
cercare di accontentarli… la qualità della carta, lo spessore,
l'inchiostro che scivola, il foglio che deve bere i colori. Angiolino,
ora, lavora per regalare alla sua cartiera la nuova funzione di documento,
di monumento, il compito forse più impegnativo. Perché,
si sa, le linee d'ombra, spesso, sono macchie indelebili.
|