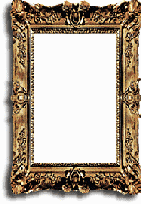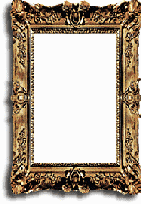|
Beni culturali. Riflessioni sopra le recenti proposte della Regione Toscana.
di Veronica
Carpita
Al clima
di fermento che, dall'istituzione della Patrimonio SpA (15 giugno 2002)
fino all'entrata in vigore del nuovo Codice Urbani sui beni culturali
e paesaggistici (1 maggio 2004), ha coinvolto volente o nolente, allarmata
o rassegnata, molta parte dell'opinione pubblica, la Regione Toscana ha
reagito proponendo due obiettivi: la "Carta dei vincoli" e un
progetto di autonomia speciale.
La cosiddetta "Carta dei vincoli", attualmente in fase di completamento,
venne presentata nel luglio 2003 e inserita nel Piano d'indirizzo delle
attività e dei beni culturali 2004-2006 (L.R. 14/95 e successive
modificazioni). Approvata in via preliminare dalla Giunta Regionale nella
seduta del 4 agosto 2003, la "Carta" consiste in una banca dati
dei vincoli archeologici, paesaggistici e monumentali, realizzata in collaborazione
con le Soprintendenze con un software appositamente progettato. La "Carta
dei vincoli" è stata realizzata grazie alla georeferenziazione,
ovvero una mappatura di tutti i vincoli imposti dalle Soprintendenze sugli
immobili e sui siti archeologici o paesaggistici di valore artistico,
storico o culturale. I vantaggi sono molteplici: la mappatura evita sprechi
di energie, tempo e denaro alle singole amministrazioni in fase di redazione
dei Piani strutturali; l'archivio informatizzato garantisce una consultazione
molto più rapida ed efficace dell'archivio cartaceo; le informazioni
dei vincoli regionali sono accessibili a tutte le Soprintendenze che hanno
così potuto riunire i loro archivi; l'aggiornamento può
essere continuo nel tempo e condiviso dagli utenti.
All'indomani dell'istituzione della Patrimonio SpA, dell'approvazione
del Codice Urbani, e del silenzio-assenso, l'opinione dell'Assessore alla
Cultura della Regione Toscana Mariella Zoppi è che la realizzazione
di questa mappatura dei vincoli della regione potrà essere uno
strumento efficace in mano alle Soprintendenze per far fronte alla dismissione
del patrimonio culturale. Se la messa a punto di analoghi progetti di
catalogazione dei beni culturali e di mappatura dei vincoli sul territorio
costituisce un lodevole impegno della regione in quanto necessario presupposto
conoscitivo di ogni attività di valorizzazione e soprattutto di
tutela, d'altro canto proprio quest'ultima incarna il secondo ambìto
obiettivo dell'ente.
È noto infatti che la Regione Toscana, che come le altre regioni
a statuto ordinario esercita la potestà legislativa in materia
di valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e ambientali (Decreto
legislativo n. 112 del 1998), ha presentato una proposta di autonomia
speciale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana che contemplerebbe
il trasferimento alla Regione di ogni attività di tutela (fino
ad oggi di esclusiva pertinenza statale). Il già citato Decreto
legislativo n. 112 del 1998 che disciplina il "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali"
ha scisso le due materie "tutela" e "valorizzazione",
appartenenti fino a quel momento alla legislazione esclusiva dello Stato,
conferendo la seconda alle Regioni. Il decreto, molto criticato per le
disfunzioni amministrative che comporta, sembrava l'estremo sviluppo della
politica del decentramento amministrativo incentivata tanto dalla destra
quanto dalla sinistra. Infatti la cosiddetta Legge Bassanini (capo I,
legge 15 marzo 1997, n. 59) non ammetteva il conferimento alle regioni
e agli enti locali delle funzioni statali riconducibili alla "tutela"
del patrimonio culturale.
Un deciso ribaltamento della situazione è stato segnato dalla riforma
del Titolo V della Costituzione (Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre
2001). All'art. 116 comma 3 è prevista infatti la possibilità
per le regioni a statuto ordinario di richiedere "ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia" in materia, fra le altre cose,
della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".
La Regione Toscana è stata la prima a decidere di avvalersi di
questa possibilità elaborando, con la consulenza del giurista Marco
Cammelli, un progetto di autonomia speciale che la Giunta ha presentato
nel maggio 2003 al Consiglio regionale. Questi in sintesi i motivi e gli
scopi dell'iniziativa: la quantità e qualità del patrimonio
storico-artistico della Toscana necessita di forme complesse di coordinamento;
il rapporto Stato-Regione non ha fatto passi avanti sul piano di una reciproca
cooperazione, ma al contrario ha conosciuto una crescente distanza. A
ciò si lega la preoccupazione della dismissione del patrimonio
culturale pubblico, oramai considerato un "correttore della finanza
pubblica"; così, le iniziative di matrice regionale sono cresciute
e si sono via via radicate nel territorio, svolgendo in qualche caso un
ruolo di supplenza là dove lo Stato è apparso carente. In
più, il trasferimento delle funzioni inerenti ai beni culturali,
attualmente esercitate dallo Stato, alla Regione e agli Enti Locali, permetterà
di ricomporre gli interventi (tutela, conservazione, valorizzazione e
gestione) e i relativi poteri (potestà legislativa, funzioni amministrative,
titolarità dei beni, personale, risorse finanziarie), e l'autonomia
potrà contribuire alla formazione di un sistema toscano della cultura
che si proponga come laboratorio progettuale di una politica culturale
unitaria, articolata in processi che tendono a obiettivi di sistema e
di stabilità.
Le ragioni addotte dai sostenitori del progetto di autonomia regionale
sono in gran parte comprensibili e in alcuni casi condivisibili. Tuttavia
esse sono state generate da una politica culturale governativa tanto della
destra quanto della sinistra che ha portato a sviluppi sconfortanti per
il nostro patrimonio nazionale e per gli operatori dei beni culturali.
La posizione della Regione Toscana, che sicuramente sarà seguita
da altre regioni nella sua iniziativa, è un correre ai ripari prima
che la situazione precipiti nell'irreparabile e per questo a molti l'autonomia
regionale potrà sembrare il male minore. Tuttavia credo sia lecito
avanzare delle obiezioni di fondo a questo progetto di autonomia speciale:
in una fase politica di progressivo decentramento delle funzioni e delle
competenze statali che così condotta fa prospettare, a mio avviso,
seri pericoli per l'esistenza dello stato sociale (vedi gli ambiti della
sanità e dell'istruzione), affidare il patrimonio culturale alle
regioni significherebbe un progressivo e inesorabile svuotamento del suo
essere componente costitutiva dell'identità nazionale, qual è
espressa nell'articolo 9 della nostra Costituzione. Inoltre, partendo
dal dato che negli ultimi anni lo Stato ha progressivamente abdicato alle
sue funzioni di tutela del patrimonio culturale, è stato carente
negli investimenti e ha dimostrato di privilegiare i valori economici
a quelli culturali, come si può pensare che le singole regioni
attuino indirizzi culturali di senso decisamente opposto? Se ciascuna
delle venti regioni italiane otterrà la piena autonomia in materia
di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale,
potendone esercitare la potestà legislativa, potremo avere venti
diverse nozioni di tutela, una per ciascuna regione. E ancora: se l'autonomia
concessa alle regioni prevedrà, come è logico che sia, competenze
esclusive in materia di gestione delle risorse finanziarie, come potranno
garantirsi standard identici per tutte le regioni, da nord a sud? È
di fronte a questo problema che la Francia, impegnata dal 1982 nel suo
processo di decentramento, ha visto scoppiare un acceso dibattito alla
vigilia della "grande braderie du patrimoine", cioè il
passo finale che consentirà allo Stato di alleggerirsi dei costi
di mantenimento del patrimonio nazionale. Il problema, infatti, è
quello di garantire la qualità e l'omogeneità dei servizi
offerti dalle regioni, cosicché non si verifichino disuguaglianze
tra i cittadini dei diversi dipartimenti. Poiché il progetto di
autonomia prevedrebbe il trasferimento dei dipendenti statali delle soprintendenze
alla regione e del personale restante impiegato in musei, biblioteche,
archivi, agli enti locali di riferimento (province o comuni), sarebbe
molto utile valutare i casi esemplari delle regioni che già dal
1975 sono autonome, ad esempio la Sicilia. Credo si rivelerebbe molto
sconfortante, per non dire frustrante come, in base al modello siciliano,
i soprintendenti fossero eletti o rimossi dall'Assessorato regionale,
cioè da una carica politica. Altrettanto pessima sarebbe la stagnazione
delle carriere che inevitabilmente ne conseguirebbe: un soprintendente
in Sicilia è nei ruoli della regione, senza possibilità
di far carriera altrove.
Concludendo, il fulcro del problema non risiede nelle regioni ma nella
politica culturale dello Stato stesso condotta negli ultimi anni. L'attuazione
di un drastico decentramento, senza un sistema centrale "forte",
non può far altro che collassare il sistema dei beni culturali.
Dunque è per il recupero del profondo valore del nostro patrimonio
nazionale che le forze politiche e culturali devono lavorare a livello
governativo. Le regioni potranno impiegare le loro energie e risorse nel
ruolo importantissimo della gestione del nostro patrimonio in un auspicato
clima di collaborazione con lo Stato.
Torna
all'inizio
|