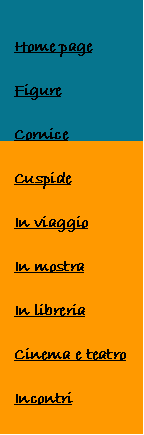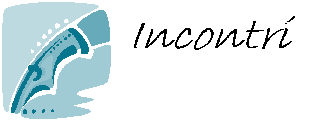|
Ormai da
molti anni l'interdisciplinarietà fiorisce nel nostro paese, e non
solo; ed in queste due giornate si sono voluti ricordare i
territorio di confine tra gli studi letterari e quelli storico
artistici e gli stimoli che riceve la ricerca quando riscopre la
validità e reversibilità del celebre precetto oraziano: ut pictura poesis.
La prima parte del convegno è stata dedicata
alle mnemotecniche e alla memoria tout court. Mary
Carruthers (New York University) ha sottolineato i particolari usi
di queste tecniche per la predicazione e la meditazione nel
Medioevo.
L'arte della memoria, conosciuta, praticata e
tramandata dai retori classici consentiva di memorizzare lunghi
discorsi, visualizzandone i contenuti in luoghi fisici percorribili.
A sostenere la fondatezza di tali tecniche è intervenuto
Lamberto Maffei (Istituto di Neurofisiologia del CNR) che ha esposto
i meccanismi su cui si fonda la memoria: l'uso di immagini. Il
deposito, enfaticamente immaginato dai retori classici, esiste
veramente nel nostro cervello ed immagazzina sotto forma di stimoli
nervosi (immagini) le esperienze vissute.
Successivamente i
lavori sono tornati a concentrarsi sul rapporto
immagini-letteratura, lasciando spazio a due giovani studiosi: Luca
Ragazzini ed Andrea Torre (Scuola Normale). Quest'ultimo ha svelato
un aspetto poco noto di uno dei poeti più noti della nostra
letteratura: Petrarca e l'arte della memoria. Nel pomeriggio
Petrarca ha continuato ad essere il protagonista dei lavori. Si è
riservata particolare attenzione al suo rapporto con l'arte
figurativa, come hanno ricordato Maria Monica Donato (Università di
Parma) e Roberto Fedi (Università di Perugia).
Il dialogo tra le
discipline ha fatto sì che trovasse spazio nel convegno anche il
cinema, che fonda la sua forza comunicativa proprio sull'unione di
parole ed immagini. La prima giornata si è chiusa con la proiezione
del Mnemonista, di Paolo Rosa, che mette in scena la tragedia
di un uomo dalla memoria prodigiosa. Una memoria ipertrofica,
involontariamente capace di utilizzare le tecniche degli oratori
classici, e che finisce per fagocitare ogni istante dell'esistenza
del protagonista, privandolo del rassicurante silenzio della
dimenticanza.
La seconda giornata è stata dedicata
all'esposizione di numerosi progetti, accomunati dalla duplice
attenzione alle parole ed alle immagini: un archivio di "sogni
letterari", un atlante delle immagini della memoria, una biblioteca
mitografica europea.
Ancora a dimostrazione dell'apertura
interdisciplinare del convegno sono intervenuti anche Ernesto Franco
(direttore editoriale Einaudi) e Stella Casiraghi (Piccolo Teatro di
Milano).
Tutti questi progetti nascono, dunque, dalla medesima
esigenza: esplorare in modo sempre più agevole gli straordinari
mondi che le due arti sorelle
hanno saputo
creare.
|
|