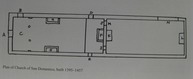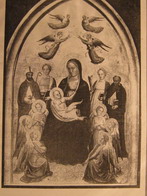Ann M. Roberts, Dominican Women and Renaissance
Art. The Convent of San Domenico of Pisa, Ashgate
2008, pp. 390, £ 60
di Linda Pisani
Èmerito degli studi di Ann Roberts, anticipati
alcuni anni addietro in un saggio (Chiara Gambacorta of Pisa as
patroness of the Arts, in Creative Women in Medieval and Early
Modern Italy: A Religious and Artistic Renaissance, a cura
di E. A. Matter e J. Coakley, Philadelphia 1994, pp.120-154), ed ora
riassunti in un volume, l’aver calamitato l’attenzione
del pubblico internazionale sull’importanza storica, assolutamente
non provinciale, del monastero di clausura femminile di San Domenico
a Pisa. Oggi, infatti, è assai difficile intuire il ruolo centrale
svolto, fra XIV e XV secolo, da tale comunità in relazione al
movimento dell’Osservanza domenicana: ciò che rimane degli
ambienti del convento è da tempo trasformato in esercizi commerciali,
e, l’annessa, piccola chiesa, affacciata su una delle vie più centrali
della città, ma spesso chiusa al pubblico, si nota a fatica,
a causa dell’aspetto volutamente dimesso della facciata (fig.
1).
Ubicato in Corso Italia (l’antica Via San Gilio), l’edificio
- ancor oggi consacrato - è da alcuni anni affidato all’ordine
dei Cavalieri di Malta che utilizzano i locali dell’ex coro delle
monache per le proprie riunioni o, più saltuariamente, per concerti
e piccole mostre. Le suore domenicane, dopo i bombardamenti subiti
dall’edificio durante l’ultimo conflitto mondiale, hanno
invece abbandonato la loro sede storica per trasferirsi nel monastero
di San Domenico Nuovo (al n. 26 di Via della Faggiola), portando con
sé, per preservarne il culto, le reliquie e le opere d’arte
di maggior valore per la devozione popolare che erano sopravvissute
in chiesa anche dopo le soppressioni napoleoniche e post unitarie.
Il convento fu fondato soltanto alla fine del XIV secolo, dunque
relativamente tardi rispetto alla sede pisana dei frati dello stesso ordine
- il prestigioso monastero di Santa Caterina - e nacque per volere di Chiara
Gambacorti. Fonte preziosa sulle sue vicende storiche resta il volume dell’erudito
pisano Nicola Zucchelli (La Beata Chiara Gambacorti, la chiesa e
il convento di San Domenico a Pisa, Pisa 1914), che rende conto di molte
indagini d’archivio. Poiché l’edificio, le opere d’arte
che gli appartengono ed anche lo stile di vita che vi si condusse sono fortemente
legati alla personalità della Gambacorti, occorrerà spendere
qualche parola sulla sua biografia, centrale, del resto, anche per il libro
della Roberts. Da fanciulla, Chiara era nota come Tora, forse diminuitivo di
Teodora, ed apparteneva alla potente famiglia mercantile dei Gambacorti, che
nel Trecento divennero per due volte signori di Pisa. Tora nacque probabilmente
a Firenze nel 1362 durante il bando di suo padre Pietro. Riammesso in patria,
per irrobustire la sua posizione politico-sociale, il Gambacorti la dette in
sposa, ancora bambina, ad un nobile pisano di nome Simone Massa. Tora rimase
però vedova soltanto tre anni dopo, appena quindicenne, e alla volontà paterna,
che avrebbe voluto per lei un nuovo matrimonio, preferì l’esempio
di Santa Caterina da Siena, incontrata a Pisa nel 1375. La giovane decise dunque,
pur fortemente osteggiata dalla famiglia, di unirsi alla comunità monastica
domenicana del convento pisano di Santa Croce in Fossabanda, incoraggiata dalla
stessa Caterina con la quale intrecciò un fitto epistolario. Fra alterne
vicende (incluso il rapimento dal monastero), la ragazza riuscì a prendere
i voti col nome di suor Chiara e presto, valutata la nuova situazione anche
dal punto di vista politico, il padre accettò il suo stato. Nel 1377
Pietro accolse a Livorno il papa Gregorio XI, che da Avignone, su incitamento
di Caterina Benincasa, stava ritornando stabilmente a Roma, e poco dopo finanziò la
costruzione di un nuovo monastero per la figlia, dedicato a san Domenico. Dodici
anni dopo, quando Chiara, a soli trentatrè anni, era ormai diventata
badessa di quel monastero, Pietro Gambacorti ed i suoi figli maschi caddero
vittima di una congiura fomentata dai Visconti di Milano. Erano anni difficili
per la città toscana, ormai lontana dai fasti dei secoli precedenti.
Nel 1398 Pisa veniva venduta dal tiranno Gherardo d’Appiano al signore
di Milano Gian Galeazzo Visconti, e poco dopo, nel 1406, veniva conquistata
da Firenze, destinata a dominarla fino al 1494. Chiara usò le ricchezze dei
Gambacorti per fare del convento anche un punto di accoglienza per ogni
sorta di bisognosi, comprese, quando lo chiesero, le donne della famiglia dei
d’Appiano, acerrima nemica dei Gambacorti. Le sue consorelle la acclamarono
santa già in punto di morte, mentre il culto come beata fu confermato
dalla Chiesa soltanto nel 1830.
Del convento pisano suor Chiara fece però soprattutto
un centro di diffusione del movimento riformatore dell’Ordine: il suo
monastero fu tra i primi a seguire le linee guida dell’Osservanza promossa
da Raimondo da Capua e Giovanni Dominici (che per un periodo fu lettore nello
studio pisano di Santa Caterina) e divenne modello di vita per altre case femminili
di nuova fondazione, come il convento di San Pietro Martire a Firenze o quello
di San Silvestro di Pisa a Genova. Il vastissimo fenomeno dell'Osservanza,
moto di riforma verificatosi all'interno di vari Ordini religiosi della Chiesa
occidentale, divenne infatti un aspetto importante della vita spirituale degli
anni intorno al 1400. Il termine ‘Osservanza’ alludeva alla tendenza
caratterizzante dei promotori di questo movimento, cioè la observantia
ad normam Regulae o la stricta observantia regularis, vale a
dire la reazione contro la decadenza o contro le attenuazioni con dispense
papali a norme qualificanti della Regola. L'Osservanza si configurò diversamente
nei vari Ordini religiosi, ma le tendenze principali del movimento si riferirono
ovunque soprattutto alla disciplina interna che avrebbe dovuto improntare l’esistenza
dei religiosi in materia di povertà e vita comune. Una caratteristica
emergente fu il radicalismo con cui si voleva rivivere l'esperienza delle origini:
la clausura, la povertà, l'ascesi, la meditazione e, a volte, persino
l'opposizione agli studi, considerati pericolosi per l'umiltà e l'obbedienza.
Celebre è la polemica del Dominici con Coluccio Salutati, nella Regola
del governo di cura familiare, in cui , nel 1401, è formulata la
condanna degli aspetti della nascente mentalità umanistica, ritenuta
paganeggiante.
Il volume pubblicato dalla Roberts si concentra sul primo secolo
dell’esistenza del monastero: dalla fondazione, avvenuta nel 1382, all’ampliamento
promosso dalle badesse Chiara Gambacorti (1395-1420) e Maria Mancini (1420-1433),
fino al completamento della prima campagna decorativa degli ambienti del monastero
e degli altari della chiesa, conclusasi verso la fine del Quattrocento.
Il testo è suddiviso in sette capitoli, agili e ben illustrati,
ed è corredato da una ricca appendice documentaria in cui sono
utilmente trascritti anche tutti gli inventari ottocenteschi dei beni
del convento. Linee guida e punti di forza nel testo della Roberts
sono l’esame della figura della beata Chiara, intesa sia come
religiosa sia come committente di opere d’arte, e la ricostruzione
del patrimonio figurativo del monastero e chiesa di San Domenico considerato
in relazione con la spiritualità delle monache. Per il primo
aspetto risulta importante la ricostruzione del sepolcro della beata,
mentre per il secondo l’attenzione si concentra soprattutto sull’iconografia
dei dipinti che un tempo adornavano il monastero.
Della Gambacorti viene messa giustamente in rilievo la ricerca
di una santità lontana dagli estremismi, e la figura che, sebbene austera,
non fece soltanto della severità il fulcro della propria vita spirituale.
Leggendo le pagine della Roberts resta infatti impresso il circuito di rinnovata
spiritualità, in cui Chiara, che può vantare come mentori santa
Caterina, il beato Dominici e Alfonso Pecha de Vadaterra (confessore di santa
Brigida di Svezia ed autore del Liber Celestis Revelationum che ne
divulgava le visioni mistiche), risulta essere inserita. La badessa si mostra
anche piuttosto illuminata dato che, pur aderendo al movimento osservante,
comprende ed incoraggia lo studio delle Sacre Scritture da parte delle monache
e si preoccupa di cercare finanziamenti, che ottiene dal mercante pratese Francesco
Datini, non soltanto per l’ampliamento del convento (realizzato
a partire dal 1395), ma anche per la carta di cui le domenicane necessitavano
per trascrivere i testi sacri. Appare certo infatti che presso il convento
fosse sorto uno scriptorium, mentre risulta plausibile che vi fosse
anche un centro di elaborazione di miniature.
Se il capitolo dedicato dalla studiosa all’analisi della
struttura architettonica del monastero e della sua chiesa mette ben in luce
come la scelta dell’ubicazione nel quartiere di Kinzica sia condizionata
dai legami familiari della Gambacorti e come l’architettura (fig. 2),
atipica fra gli edifici pisani, sia il riflesso degli ideali dell’Osservanza
(per la struttura con una chiesa doppia, comprensiva del cosiddetto coro delle
monache collegato alla chiesa dei laici soltanto da due grate, e per la facciata
disadorna), ancor più approfondita è la disamina del sepolcro
della beata e degli aspetti di devozione e propaganda religiosa ad esso collegati.
Poco dopo la scomparsa della badessa, nel 1420, il suo corpo fu tumulato ai
piedi dell’altare nella chiesa interna; la tomba terragna venne chiusa
con una lastra marmorea recante l’effigie di Chiara con in mano un giglio
e racchiusa da un baldacchino goticheggiante dai cui pennacchi si affacciano
due angeli adoranti (fig. 3). Credo che l’autrice abbia ragione nel confrontare
questo rilievo, almeno per l’impaginazione ancora fortemente compromessa
con modi gotici, e per la solennità dell’immagine, con esempi
pisani di inizio secolo, come una lastra tombale nella chiesa pisana di San
Francesco, cui si potrebbero aggiungere anche altre occorrenze tardotrecentesche,
come le tombe dell’orefice Domenico di Ranieri e dell’arciprete
Ranieri da Ripafratta, entrambe nel Battistero pisano, oltre a quella, segnalata
da Roberto Paolo Ciardi (Scultura a Pisa tra Quattro e Seicento, a
cura di Idem, L. Tongiorgi, C. Casini, Pisa 1987, p. 17 e nota 45), di Martino
Coscia, oggi al Louvre, scolpita nel primo Quattrocento per la chiesa pisana
di Santa Caterina. Una notizia documentaria, già ben nota, ci informa
che uno scalpellino di nome Giovanni rese vari servigi al monastero delle terziarie
domenicane nel periodo della scomparsa della badessa, ma finora qualsiasi tentativo
di riferirgli la realizzazione del rilievo sepolcrale o di farne una figura
storicamente individuabile deve rimanere confinato nel limbo delle ipotesi.
D’altra parte, come evidenzia la Roberts, presentare la beata pisana
semplicemente con un giglio in mano sembra anche un’allusione al suo
legame con Caterina Benincasa, tradizionalmente identificata da quell’attributo.
Come riferisce la stessa studiosa, facendo tesoro delle fonti manoscritte conservate
presso l’archivio diocesano di Pisa (specie i preziosi appunti del canonico
settecentesco Ranieri Zucchelli, che cita, a sua volta, un liber memorialis della
fine del XVI secolo), nel 1432, tredici anni dopo la scomparsa della Gambacorti
e in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione del monastero,
il suo corpo fu collocato in una cassa di cipresso e la sua lapide venne posta
in una nicchia a cornu evangeli dell’altar maggiore decorata
ad affresco con la raffigurazione della Crocifissione a cui assistono san
Domenico ed una piccola monaca beata, nella quale ab antiquo viene
indicata un’effigie della stessa Chiara. In fondo al coro delle monache,
sulla parete sinistra, si staglia infatti ancor oggi un arcosolio con, nella
parete di fondo, un’immagine della Crocifissione, e nell’intradosso
e nella fronte dell’arco i tredici busti clipeati di Cristo e degli apostoli
(figg. 5-7). La struttura appare molto tradizionale e simile a quella delle
tombe ad arcosolio che nel corso del XIV secolo si potevano facilmente incontrare
nei cimiteri italiani, come, per fare un esempio geograficamente prossimo,
una tomba – anch’essa decorata da busti di profeti reggicartiglio
inseriti entro clipei – nel cimitero di Santa Caterina nel chiostro della
basilica lucchese di San Frediano. Nel 1828, alcuni esperti di belle arti,
fra cui Carlo Lasinio, convocati dall’arcivescovo Ranieri Alliata, si
recarono nella chiesa di San Domenico per un sopralluogo. Dalla loro relazione,
citata nel volume della Roberts, si evince con certezza che, allora, lastra
e affresco costituivano un unicum. Il bassorilievo (88 x 234 cm) era
appoggiato sulla mensola interna dell’arcosolio (65 x 238), sporgendo
da esso di diversi centimetri. Posso aggiungere che la situazione era rimasta
pressoché invariata più di trent’anni dopo, quando il pittore
pisano Annibale Marianini descriveva una “lunetta a fresco… Cristo
in Croce con le Marie, san Giovanni, san Domenico, la beata Chiara. Nell’archivolto
in tredici formelle centinate Cristo e li Apostoli. Contiene la tavola di marmo
che chiude il corpo della Beata Chiara fondatrice col ritratto in bassorilievo
opera del Trecento assai bene conservata” (cfr. A. Marianini, Inventario
dei Beni artistici nel compartimento di Pisa. 1860-1863,, a cura di M.G.
Burresi, Pontedera 2008, p. 73). D’altronde, si può ancora notare
come la lunga epigrafe (Hic jacet devotissima religiosa soror clara vita
et miraculis gloriosa Priorissa, atque fundatrix huius monasterij filia olim
magnifici domini Petri de Gambacortis), correndo tutt’intorno al
bordo esterno della lastra, renda difficile immaginare che quest’ultima
fosse stata concepita per essere appoggiata al muro sotto l’affresco,
e inoltre, come mi fa notare Gerardo de Simone, proprio all’inizio del
Quattrocento fra i sepolcri di monache si incontrano esempi con lastre incassate
e sporgenti da arcosoli, probabilmente concepiti quasi come altari (fig. 4).
Un discorso a parte merita la scelta del pittore, giustamente identificato
da Mariagiulia Burresi (Affreschi medievali pisani, Pisa 2003, p.
138) in Turino Vanni. Si tratta di un artista, come hanno chiarito gli studi
di Antonino Caleca, non innovativo, ma molto prolifico ed altrettanto longevo.
Nel 1433, anno in cui dovette esser realizzato l’affresco, aveva ormai
fatto ritorno a Pisa, dopo un lungo soggiorno in Liguria. Rilievo, decorazione
ad affresco e struttura del sepolcro rispondono dunque ad una tipologia di
retaggio ancora trecentesco, piuttosto arcaicizzante se pensiamo che a Pisa,
già da alcuni anni, Masaccio aveva portato a termine un polittico tanto
moderno come quello del Carmine, oggi smembrato fra varie sedi museali.
Se il sepolcro fu approntato dopo la scomparsa della badessa,
sappiamo peraltro che lei stessa aveva fortemente incoraggiato, durante gli
anni del suo priorato, la decorazione del monastero pisano. Come ha precisato
l’indagine della Roberts, sono molteplici le committenze che si possono
riferire al periodo in cui Chiara fu alla guida del convento: fra queste si
segnalano molte opere oggi nel Museo Nazionale di San Matteo, come la tavola
con lo Sposalizio mistico di Santa Caterina dipinta da Martino di
Bartolomeo, lo Sposalizio mistico di Santa Caterina da Siena, dovuta
ad un anonimo artista pisano (a mio avviso, forse, da riconoscere in Cecco
di Pietro), la Crocifissione su tela di Giovanni di Pietro da
Napoli, il polittico di Martino di Bartolomeo raffigurante la Madonna col
Bambino e santi (con la predella raffigurante Storie di Santa Brigida alla
Gemaeldegalerie di Berlino), il polittico di Francesco d’Antonio (il
cui scomparto centrale è conservato al Denver Museum of Art, mentre
i laterali, con due santi ciascuno, sono nel museo pisano, fig. 9).
Anche dopo la scomparsa della Gambacorti, non venne meno l’attenzione
per l’ornamentazione dell’edificio che continuò ad
accogliere opere di artisti pisani, come Borghese di Piero, autore
del San Girolamo nello studio e nel deserto conservato al
Museo di san Matteo a Pisa (fig. 8), o Niccolò dell’Abbrugia,
cui si deve un paliotto ligneo con Cristo in pietà oggi
a San Domenico Nuovo, ma anche forestieri, come Bicci di Lorenzo, Beato
Angelico, il fiammingo Maestro della Leggenda di Santa Lucia, Paolo
Schiavo, Benozzo Gozzoli e Ambrogio d’Asti. Se Creigthon Gilbert
(Tuscan Observants and Painters in Venice c. 1400, in Interpretazioni
veneziane: studi di Storia dell’arte in onore di Michelangelo
Muraro, a cura di D. Rosand, Venezia 1984, pp. 109-120) aveva
identificato in un’anconetta dipinta da Andrea di Bartolo verso
il 1394 e raffigurante la Vergine dell’Umiltà e il
Crocifisso, oggi alla National Gallery di Washington, un esempio
della decorazione delle celle delle monache domenicane nel convento
osservante di Venezia, la Roberts riesce dunque a ricostruire molto
più in dettaglio i gusti del corrispondente contesto pisano.
È bene dire subito che il testo risulta abbastanza spesso poco informato,
o ingiustamente cauto e laconico, per tutto ciò che riguarda identificazione,
stile o carriera degli artisti. È invece sul piano della lettura iconografica
dei dipinti che il libro si fa più interessante; nei soggetti si ravvisano
le tematiche in cui le monache di clausura potevano più facilmente immedesimarsi,
come le raffigurazioni delle vergini martiri (come Eulalia ed Orsola), o gli
sposalizi mistici (di santa Caterina d’Alessandria e di santa Caterina
da Siena), quelli che potevano ricordare loro il compito di pregare per la
salvezza dei propri congiunti (la Resurrezione di Lazzaro o Cristo fra Marta
e Maria Maddalena), invitarle ad esperienze di misticismo (come nel caso
di santa Brigida di Svezia), ribadire l’importanza del silenzio (con
la raffigurazione di san Domenico che invita ad esso) e propagandare nuovi
culti sostenuti dall’ordine domenicano (come quello dei diecimila martiri). L’autrice
chiarisce, ad esempio, con i legami documentati fra le monache e l’ordine
francescano, la vistosa presenza di san Francesco ai piedi della Croce nella Crocifissione di
Giovanni di Pietro da Napoli e la commissione del dipinto da parte del frate
francescano Stefano Lapi. Apprendiamo così che sin dal 1402 il Capitolo
generale dei francescani aveva concesso alle monache di San Domenico la facoltà di
partecipare ai benefici spirituali dell’ordine francescano ma anche che
il Lapi era amico personale di Chiara e con figlie e moglie fattesi monache
a San Domenico. Un buon approfondimento è offerto anche per il polittico
dipinto da Martino di Bartolomeo ed un tempo sull’altar maggiore della
chiesa pubblica. La Roberts ne collega infatti la realizzazione ad un lascito
del 1405 da parte di una zia della Gambacorti di nome Giovanna, e sottolinea
come l’insistenza sulla raffigurazione di santa Brigida (protagonista
di tutte le scene della predella) si debba alle scelte personali di Chiara,
che aveva conosciuto il confessore della santa, Alfonso de Vadaterra, e che
doveva avvertire la spiritualità della mistica svedese particolarmente
prossima alla propria. Brigida era infatti stata proclamata santa soltanto
pochi anni prima, nel 1391, ed il suo nome non era ancora incluso nel calendario
domenicano, perciò, dandole così tanto spazio proprio nel dipinto
destinato all’altar maggiore della chiesa esterna, Chiara si faceva di
fatto promotrice del suo culto. Interessante è anche la ricostruzione
della genesi del trittico dedicato a santa Caterina d’Alessandria in
cui, alla tavola centrale dipinta su legno di quercia da un maestro fiammingo,
e probabilmente spedita dalle Fiandre, furono uniti due laterali eseguiti da
un pittore pisano che, per le scene della predella, trasse ispirazione dalle
incisioni fiorentine di Francesco di Lorenzo Rosselli. Considerando come, trattandosi
di un monastero femminile, all’interno della struttura non fossero permesse
né sepolture di laici né cappelle gentilizie, o ancora come le
monache non avvertissero il bisogno di un numero elevato di altari, non avendo,
a differenza di molti frati, l’obbligo di officiare, colpisce ancora
di più la quantità di opere d’arte realizzate per l’edificio
pisano. Dipinti, ceri pasquali issati su bastoni decorati (come quello di Cecco
di Pietro oggi al Museo di San Matteo) e sculture, dovevano essere dislocati
sugli altari, che, stando all’autrice, nella seconda metà del
XV secolo sarebbero stati tre nella chiesa esterna e quattro in quella interna;
mentre gli spazi comuni del monastero erano abbelliti da affreschi, e altri
dipinti di formato minore dovevano trovarsi sugli altari dei dormitori delle
monache, come è stato appurato nel caso della già citata tavoletta
di Borghese di Piero (fig. 8) con San Girolamo penitente e nello studio ed
una devota domenicana (cfr. A. Thomas, Art and piety in the female
religious communities of Renaissance Italy. Iconography, space and
the religious women’s perspective, Cambridge 2003, pp. 13-21 e 123).
La Roberts sottolinea inoltre come, sebbene osservanti, le monache
di San Domenico dovettero per lungo tempo dipendere giuridicamente
dai frati (non osservanti) di Santa Caterina, poiché, come ogni
convento femminile dell’ordine, anche quello pisano faceva riferimento,
per la cura monialium, dalla congregazione maschile più vicina.
Si può comprendere come si trattasse di una ‘difficile
convivenza’ e come quando, nel 1488, anche i frati di Santa Caterina
si unirono al ramo osservante, tale evento trovò immediato riflesso
nelle opere d’arte del monastero femminile, in cui il riecheggiamento
di quelle della casa madre fiorentina, cioè il convento osservante
di San Marco, poté finalmente risultare palese. Fu forse in
tali frangenti che a Pisa giunse la tela con la raffigurazione del Cristo
eucaristico dipinta dal Beato Angelico (oggi al Museo di san Matteo),
mentre certamente in questi anni furono realizzati l’affresco
del chiostro con un San Domenico che incita al silenzio (tema che si
incontra anche a San Marco) e la Crocifissione dipinta da
Benozzo nel Refettorio, per la quale la Roberts indica a modello l’Allegoria
della Crocifissione nella Sala Capitolare del convento fiorentino.
Fin qui i meriti di questo volume, ma occorrerà dire anche delle
critiche. In primo luogo, sarebbe piaciuto trovarvi anche qualche riferimento
all’ulteriore attività di questi artisti, almeno per capire
se i forestieri, quando lavorarono per le domenicane, erano già conosciuti
in città, oppure se lo furono in seguito, quasi che l’attività per
San Domenico fosse loro valsa da trampolino di lancio sulla scena locale.
Per esempio, del pittore fiorentino Francesco d’Antonio, di cui
si mette ben in evidenza, nel trittico dipinto per le suore (fig. 9),
la scelta di una carpenteria semplice e quasi arcaicizzante, si poteva
forse sottolineare come questa fu ragionevolmente la prima opera pisana,
seguita però da una consistente attività per la città,
segnalata dai documenti (dov’è citato all’inizio
degli anni quaranta) e da alcune opere superstiti (come gli affreschi
- Crocifissione ed I santi Cosma e Damiano - della
controfacciata della Cattedrale) ed altre da riferirgli (come la Vergine
incoronata fra Santi, affresco staccato e parte di un palinsesto,
nella basilica di San Piero a Grado, che a mio avviso gli spetta, fig.
11 – la si confronti ad esempio con la Madonna col Bambino oggi
alla National Gallery di Londra, fig. 10). Di Borghese di Piero, invece,
si poteva ricordare come il San Girolamo nello studio e nel deserto (fig.
8), già ampiamente indebitato con le novità masaccesche,
sia di fatto l’unica opera pisana nota di un artista che, a dispetto
delle sue origini e del possibile alunnato col pisano Battista di Gerio
(sotto la cui egida, a mio avviso, dovette dipingere anche quest’anconetta
venduta a Budapest nel novembre 1917 con la collezione di Hugo von
Kilènyi, che conosco solo dalla pagina del catalogo d’asta
e che viene qui riprodotta nella speranza che riemerga dal nulla, fig.
12) fu attivo pressoché esclusivamente per Lucca.
È doveroso inoltre menzionare alcuni altri studi recenti
sul patrimonio artistico di San Domenico, usciti poco prima o in contemporanea
alla pubblicazione del volume della Roberts. In due saggi di G. de Simone[1] si
rintraccia un tondo raffigurante un Cristo in Pietà (oggi a
San Domenico Nuovo), attribuito a Niccolò dell’Abbrugia, viene
rivalutato un Crocifisso ligneo di primo Trecento un tempo ritenuto
miracoloso, e viene approfondito il finora trascurato Cristo benedicente dipinto
su tela dal Beato Angelico. Si segnala poi un testo, in vero di non facile
reperibilità (M. Burresi, Opere d’arte del Trecento e del
Quattrocento della chiesa e del monastero di San Domenico, in L’arte
e la storia, incontri tra il Sovrano Militare Ordine di Malta e gli Amici dei
Musei e Monumenti pisani, Pisa 2007, pp. 101-120), che offre una ricognizione
delle opere d’arte realizzate fra Tre e Quattrocento per la chiesa pisana
in cui si possono trovare valide integrazioni al patrimonio preso in considerazione
dalla Roberts (che infatti non tutela le sculture), come l’Annunciata lignea
scolpita da Agostino di Giovanni nel 1321, la Madonna col Bambino di
scultore renano del Trecento, ed un’altra Annunciata lignea
dell’ambito di Francesco di Valdambrino, opere oggi tutte confluite nella
raccolta del Museo Nazionale di San Matteo.
1.Da
San Domenico, Pisa: un inedito Cristo in pietà di Niccolò Pisano,
in ‘Commentari d’arte’, 9/12, 2006, pp. 5-11; L’Angelico
di Pisa: ricerche e ipotesi sul “Redentore benedicente” del
Museo Nazionale di San Matteo, in ‘Polittico’, 5,
2008, pp. 5-35.

1- Facciata della chiesa di San Domenico, Pisa
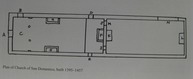
2- Ricostruzione della pianta antica della chiesa di San Domenico, Pisa

3- Sepolcro della beata Chiara Gambacorti, lastra tombale, Pisa, chiesa di San Domenico Nuovo

4- Sepolcro di una monaca, XV secolo, Basilea, Barfüsserkirche-Historisches Museum

5- Turino Vanni, Crocifissione con san Domenico e la beata Chiara, Pisa, chiesa di San Domenico

6- Turino Vanni, Crocifissione con san Domenico e la beata Chiara (dettaglio), chiesa di San Domenico, Pisa

7- Turino Vanni, Crocifissione con san Domenico e la beata Chiara (dettaglio), chiesa di San Domenico, Pisa

8- Borghese di Piero, San Gerolamo penitente e nello studio con una devota domenicana, Museo Nazionale di San Matteo, Pisa

9- Francesco d’Antonio Banchi, I santi Domenico e Michele Arcangelo, Museo Nazionale di San Matteo, Pisa

10- Francesco d’Antonio Banchi, Madonna col Bambino e angeli (dettaglio), National Gallery of Art, Londra

11- Francesco d’Antonio Banchi, Madonna col Bambino (dettaglio), basilica di San Piero a Grado, Pisa
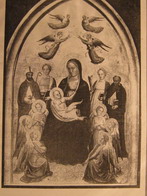
12- Borghese di Piero, Madonna col Bambino e angeli (qui attribuito), ubicazione ignota
Chiara Piva, Restituire l’antichità. Il laboratorio di restauro della scultura antica del Museo Pio-Clementino, Edizioni Quasar, Roma 2007
di Ilaria Sgarbozza
È la seguente, densa, affermazione di Marguerite Yourcenar ad introdurre il lettore al lodevole saggio Restituire l’antichità. Il laboratorio di restauro della scultura antica del Museo Pio-Clementino: «Dal giorno in cui una statua è terminata, comincia, in un certo senso, la sua vita». È proprio su uno dei momenti nodali della secolare vita delle sculture antiche, il restauro, che si sofferma, in effetti, Chiara Piva, studiosa di formazione romana già autrice di numerosi contributi sulla teoria e la pratica del restauro delle antichità in età moderna. Piva scandaglia, in particolare, la vicenda, finora trascurata, del laboratorio di restauro annesso al Museo Pio-Clementino in Vaticano, attivo per circa un ventennio, tra gli anni Settanta e gli anni Novanta del XVIII secolo, quando la febbre dell’antico investì la città del Papa, centro del Grand Tour e capitale delle arti. Così facendo, completa la ricostruzione della genesi del più importante museo di antichità dell’Europa moderna; una ricostruzione avviata negli anni Ottanta da Carlo Pietrangeli e condotta successivamente da Gian Paolo Consoli, Paolo Liverani e Orietta Rossi Pinelli, ai quali spetta il merito di aver indagato le scelte architettoniche ed espositive dei fondatori.
Piva interpreta l’attività del laboratorio annesso al Pio-Clementino come l’emanazione delle direttive impartite da Giovanni Battista ed Ennio Quirino Visconti, primi direttori del museo e autori (in particolare il secondo) di un catalogo in folio delle opere della collezione considerato la massima testimonianza del livello di erudizione raggiunto dalla cultura antiquaria romana settecentesca. Nato per ridurre i costi del restauro in atelier (ovvero del trasferimento dei marmi antichi dal Vaticano agli studi degli scultori, concentrati per lo più nella zona del Tridente), il laboratorio si afferma sulla scena capitolina di fine secolo come un privilegiato luogo di dialogo e scambio tra antiquari e artisti-restauratori. Nei suoi locali la collaborazione virtuosa tra gli uni e gli altri produce la messa a punto di quella metodologia di restauro finalizzata alla restituzione dell’originaria identità iconografica ed estetica dell’opera d’arte, che è una delle più significative conquiste ed eredità dell’età neoclassica.
Senza indugiare in considerazioni di carattere teorico o ideologico, facendo piuttosto ricorso ad un’ampia e inedita documentazione d’archivio, l’autrice disegna la fisionomia, il funzionamento e l’organizzazione dell’atelier. Ne stabilisce l’ubicazione non lontana dalla Torre dei Venti, nella parte settentrionale del Cortile del Belvedere, a ridosso delle sale espositive. Si occupa di ricostruire dettagliatamente le varie fasi dell’intervento di restauro, così come danno ad intendere la manualistica settecentesca (gli scritti di Bartolomeo Cavaceppi e Francesco Carradori, in particolare) e le relazioni e note di spesa presentate ai Visconti dal personale dell’atelier. Dall’eliminazione dei depositi presenti sulla superficie marmorea, alla realizzazione delle integrazioni, alla lustratura finale, il metodo di lavoro viene così messo a nudo, rivelandosi un’operazione lunga, complessa e coinvolgente numerose professionalità. Proprio l’elencazione delle professionalità attive all’interno del laboratorio è un punto centrale dello scritto, che svela l’esistenza di una schiera di tecnici specializzati, organizzata secondo una rigida suddivisione dei compiti e sottoposta a un diversificato trattamento salariale. In Vaticano scultori, intagliatori, scalpellini, lustratori, segatori cooperano, trasmettendosi generalmente l’impiego di padre in figlio. Sono tutti alle dipendenze di un “sovrintendente ai restauri”, nominato dal direttore del museo, il quale ha libertà di scelta dei fornitori e dei collaboratori saltuari. Ai due “sovrintendenti” che si succedono, Gaspare Sibilla (1723-1782) e Giovanni Pierantoni (1742-1817), l’autrice dedica uno spazio speciale. In particolare, del secondo ricostruisce l’intera biografia, dagli esordi nella bottega di Cavaceppi, alla maturità, spesa tra attività di restauro, di scavo, di intermediazione nel mercato antiquario e attività più propriamente artistica, all’età avanzata, quando è investito dalla crisi finanziaria che si abbatte sullo stato pontificio ed è costretto a disfarsi della propria collezione di opere d’arte antiche e moderne. Quanto all’incidenza dei costi del laboratorio di restauro sul budget annuale del Pio-Clementino, Piva rielabora statisticamente i dati forniti dalla documentazione archivistica per arrivare a riconoscerne il valore massimo tra la fine degli anni Ottanta e i primissimi anni Novanta, quando, terminati i lavori architettonici, il definitivo ordinamento delle sale diviene la priorità dei curatori. Tra il 1780 e il 1791 l’impiego di lavoranti cresce pressoché costantemente, mentre il 1793 è il momento del crollo delle commesse, coincidente con la depressione economica che, sotto l’incalzare degli avvenimenti internazionali, colpisce la città.
Creatura di Pio VI, l’ultimo papa mecenate, e simbolo, in nome del primato della cultura classica, dell’universalismo artistico romano, il Museo Pio-Clementino, nel suo assetto e nella sua organizzazione originaria, non sopravvive alla Rivoluzione francese. A partire dal 1796 si perdono le tracce del laboratorio di restauro; un anno più tardi gli inviati del direttorio, in testa Gaspar Monge, imballano i più celebri capolavori, non di rado appena usciti dall’atelier della Torre dei Venti, con destinazione Louvre.
È all’interno dell’ampia riflessione sul primato di Roma nelle arti e nell’elaborazione della moderna scienza della conservazione che il libro di Chiara Piva deve essere dunque inquadrato. La straordinaria e breve storia del laboratorio guidato da Sibilla e Pierantoni racconta molto del debito che l’istituzione-museo, così come si è venuta configurando in Occidente tra XIX e XX secolo, ha contratto con la città dei papi. Che i responsabili dei musei pubblici europei abbiano apprezzato la metodologia integrativa e il processo di lavorazione messi a punto in Vaticano è d’altronde incontestabilmente dimostrato dall’arruolamento, nei primi decenni dell’Ottocento, di un gran numero di scultori, scalpellini e lustratori in fuga, per necessità o per scelta, dalla declinante capitale dello Stato Pontificio.

La copertina del volume
Maurizio Tani, La rinascita culturale del ‘700 ungherese. Le arti figurative nella grande committenza ecclesiastica, Roma, Gregorian University Press, 2005
di Emanuele Pellegrini
La porzione orientale dell’Europa conosce nel corso del diciottesimo secolo la significativa emersione di alcuni paesi capaci di giocare un ruolo centrale nelle vicende politiche e quindi negli equilibri dell’intero continente. Essi attivano fitti dialoghi con gli altri paesi, giungendo a vivere stagioni da protagonisti anche dal punto di vista culturale, attirando artisti e proponendo soluzioni mecenatizie di indubbio livello, che in qualche caso si sono ripercosse pure sulla storia civile e culturale del resto dell’Europa. La Polonia di Stanislao Augusto Poniatowski, e soprattutto la Russia degli illuminati zar Pietro e Caterina, sono senz’altro gli esempi principali.
Tuttavia non sono gli unici. Il volume di Maurizio Tani viene, infatti, a illuminare in maniera molto approfondita la situazione culturale dell’Ungheria del diciottesimo secolo, quella parte che si potrebbe definire “di confine” del grande colosso dell’impero austriaco. Tani riesce a spiegare in modo chiaro quanto complicata fosse la situazione ungherese a livello geo-politico, e di conseguenza anche culturale, proprio per questa sua posizione tra l’Europa, il sempre minaccioso Impero Ottomano, e l’Oriente; tuttavia il cuore del suo studio si rivolge allo straordinario rapporto creatosi tra mecenati ed eruditi ungheresi e l’Italia, decisivo per quella che l’autore definisce la “rinascita culturale” ungherese del Settecento. La sua minuziosa ricerca pone, infatti, in evidenza le feconde relazioni tra la classe colta magiara e la cultura italiana lungo tutto il corso del diciottesimo secolo, soprattutto con la città di Roma. Tani dimostra con dovizia di particolari il ruolo centrale che una giovanile formazione italiana giocò nella vita dei molti ungheresi, rientrati poi in patria e qui presto divenuti protagonisti attivi nella vita delle proprie città e diocesi, in cui si enumerano molte nuove commissioni, ristrutturazioni, riordinamenti di biblioteche, fondazione di colonie arcadiche. Ne derivò un tangibile incremento degli studi, regolato sull’esempio di eruditi coevi come Muratori e Maffei, il cui museo lapidario sarà “replicato” difatti in alcune residenze ungheresi: già Luigi Ferdinando Marsigli nel suo Danubius Pannonicus-Mysicus, edito tra 1726 e 1744, aveva avuto modo di segnalare il ricco materiale archeologico presente in alcune collezioni ungheresi. E basti poi pensare a figure come quella di Michele Federico Althann, vicerè di Napoli e pastore arcade, significativamente ritratto dal Solimena nella tela Il conte Althann offre all’imperatore Carlo VI il catalogo della Pinacoteca imperiale (fig. 1), oggi conservata a Vienna.
Il contributo della ricerca di Maurizio Tani consiste essenzialmente in una mediazione culturale tanto rara quanto cospicua, essendo l’autore madrelingua ungherese e quindi capace di proporre al pubblico, in primo luogo italiano, una quantità di materiale altrimenti inaccessibile, dato soprattutto l’ostico ostacolo linguistico. Il libro possiede un innegabile valore in un duplice senso: intanto perché rischiara le complesse e poco note vicende della vivacissima cultura ungherese del diciottesimo secolo - con frequenti e non marginali rimandi ai secoli precedenti sino al “mito” rinascimentale di Mattia Corvino -, ossia un periodo ricco di studiosi, mecenati e anche artisti, tanto da permettere di definire gli anni 1740-1780 una vera e propria rinascita culturale. In secondo luogo perché contribuisce in misura non inferiore alla precisazione di taluni aspetti del contesto romano settecentesco, notoriamente articolato e giunto forse all’acme del suo plurisecolare cosmopolitismo, in merito a cui si aggiungono alcune utili informazioni, specialmente inerenti la produzione degli artisti italiani per la committenza ungherese. Una serie di maestranze queste, dagli architetti agli argentieri (Gaetano Nesi, Vincenzo Milione, Gaetano Pesci, Giuseppe Agricola), a volte ancora ben poco conosciuta e su cui Tani ha modo di aggiungere documenti e opere. Ad essi si associano non marginali notazioni a proposito del mercato artistico e della produzione di copie, segnatamente dei numerosi capolavori italiani (Maratti e Reni su tutti) richiesti per arredare chiese e collezioni d’Ungheria, spesso costruite dichiaratamente «ad normam italicam» (p. 102). Per non parlare infine delle incisioni, che gli ungheresi compravano in largo numero al fine di addobbare residenze private e studioli, dove domina il nome di Piranesi, le cui vedute divengono a loro volta fonte primaria per motivi decorativi (pp. 148-152). Tanto che in qualche caso si creano interessanti situazioni di resistenza alla “romanizzazione” che portava ad eliminare le caratteristiche più antiche, ma autoctone, degli edifici ungheresi, con contrasti aspri tesi a contrapporre la forma «gothica» a quella «romana» (ad esempio pp. 131-133: temi che lo stesso Tani aveva in parte svolto in un recente e documentato articolo apparso sulla rivista “Commentari”, 15/17, 2000).
Particolare attenzione viene poi giustamente deputata a quegli edifici che costituirono un coagulo per la comunità ungherese a Roma, come il Collegio Germanico e Ungarico, le chiese di Santo Stefano Rotondo e Santo Stefano degli Ungheresi; oppure a quelle iniziative di cultura promosse dagli stessi ungheresi in Italia, tra cui sarà debito segnalare il ben noto «Diario ordinario di Chracas», fondato a Roma nel 1716, e che costituisce ancora oggi una miniera di informazioni utili sulla Roma settecentesca. Una duplicità di riferimenti, quindi, italiani, e soprattutto romani, e ungheresi, che trova una decisiva premessa e un saliente trait d’union nel «ruolo egemone svolto dalla Chiesa romano-cattolica nell’Ungheria del Settecento» (pp. 24 e sgg.).
Numerose infine sono le notizie, anche biografiche, su studiosi ungheresi, spesso in stretto collegamento con gli eruditi italiani. Larga parte della notazione del volume mira proprio a ricostruire il profilo biografico degli ungheresi che ebbero rapporti stretti con l’Italia. A volte essa risulta persino eccessiva, arrivando a coprire intere pagine e in qualche caso affatica od ostacola lo svolgimento della lettura. Soprattutto anche perché molte di queste stesse notizie, che sono state poste all’interno delle note, aggiungono informazioni non semplicemente accessorie o di complemento, bensì assai utili alla precisazione del quadro ricostruito nel volume e sarebbero potute stare tranquillamente nel testo.
Resta, infine, da segnalare ancora l’appendice documentaria e un’utile bibliografia, che completano il quadro di un lavoro senz’altro utile per gli studi italiani, soprattutto perché veramente originale, tanto che si spera non manchino in futuro ulteriori approfondimenti.

Francesco Solimena, Il conte Gundaker Althann offre all’imperatore Carlo VI il catalogo della Pinacoteca imperiale, 1728, olio su tela, cm 209 x 284, Vienna Kunsthistorisches Museum
Scarica in versione pdf  |