Nuova luce sull’Armadio degli Argenti
recensione di: Creighton Gilbert, Lex Amoris. La legge
dell’amore nell’interpretazione di Fra Angelico, Firenze,
Le Lettere, 2005, pp. 120, euro 14
di Gerardo de Simone
L’Armadio degli Argenti è una delle opere più complesse
e affascinanti del Beato Angelico, ma anche, nonostante la notorietà delle
singole scene, tra quelle non ancora sufficientemente studiate nel
suo insieme. È così chiamato, metonimicamente, in quanto
i trentasei scomparti quadrati che lo compongono – per un totale
di trentacinque episodi, il Giudizio Finale occupa due scomparti – in
origine fungevano da ante esterne dell’armadio ligneo che custodiva
le preziose offerte votive (gli “argenti”, appunto) destinati
dai fedeli all’affresco dell’Annunciazione venerato
nella chiesa fiorentina della SS. Annunziata, collocato a sinistra
dell’ingresso principale e incorniciato dal monumentale tabernacolo
commissionato da Piero de’ Medici – committente anche dello
stesso Armadio – a Michelozzo e Pagno di Lapo Portigiani
(1448). L’armadio era posto dietro il tabernacolo, nella
prima cappella sinistra: il sistema convenzionale di apertura ad ante
fu sostituito nei primi anni sessanta del Quattrocento da un più ingegnoso
meccanismo a “cateratta”, cioè a saracinesca azionata
da una carrucola (si vedano in proposito gli studi di E. Casalini,
in “Commentari”, 14, 1963 e La SS. Annunziata di Firenze.
Studi e documenti, Firenze 1971), con ogni probabilità per
consentire un migliore accesso al vano della cappella. L’agile
volumetto di Creighton Gilbert – pubblicato direttamente in traduzione
italiana –, segna un decisivo progresso nella vicenda critica
dell’opera, e ne chiarisce in modo risolutivo la lettura.
Gilbert infatti, recuperando un’indicazione presente sì in
precedenti, lontani studi sulle tipologie biblico-iconografiche – A.
von der Gabeläntz, Die Kirchliche Kunst im italienischen Mittelalter,
Strasbourg 1907, e H. Cornell, Biblia Pauperum, Stockholm
1925 – ma finora del tutto trascurata nella bibliografia angelichiana,
ha rintracciato in un manoscritto illustrato della Biblioteca Marciana
di Venezia (Ms. Lat. I, 72 [=2501]) la puntuale fonte iconografica
e testuale dell’intera opera. Come è noto, l’Armadio
degli Argenti illustra nove episodi dell’infanzia di Cristo,
dall’Annunciazione alla Disputa tra i dottori, tre relativi alla
vita adulta di Cristo (Nozze di Cana, Battesimo, Trasfigurazione, spettanti
alla mano di Alesso Baldovinetti), venti storie della Passione (dalla
Resurrezione di Lazzaro alla Pentecoste) seguite dal Giudizio Finale
e da altri due pannelli. Aprono e chiudono la serie due riquadri più complessi:
il primo mostra uno schema, tipico dei trattati di mnemotecnica, a
doppia ruota concentrica, con i quattro Evangelisti e i quattro apostoli
autori del Nuovo Testamento in quello interno, dodici profeti in quello
esterno, a evidenziare il tema canonico della concordia Veteris
ac Novi Testamenti che informa tutto il ciclo narrativo; nei due
angoli inferiori le figure accovacciate di Ezechiele e di S. Gregorio
Magno, i cui passi rispettivi sono riportati negli angoli superiori – quello
del profeta è infatti la fonte della “rota in medio
rotae”, quello di Gregorio ne è il commento. Coerentemente,
tutti gli episodi del ciclo sono incorniciati da due cartigli, uno
in basso relativo al corrispondente passo evangelico, l’altro,
in alto, indicante il precedente veterotestamentario. Nell’ultimo
appare, sotto forma di una personificazione femminile, la Lex Amoris,
ma gran parte del campo pittorico è occupata da una sfilza di
cartigli affissi su di un candelabro a sette braccia e ai lati della
croce d’oro svettante dal braccio centrale del candelabro, chiara
simbologia della superiorità del Nuovo Testamento sul Vecchio:
tale immagine è tratta, come per primo si avvide Orlandi (Beato
Angelico, Firenze 1964, p. 120), da un passo della Summa Theologica di
S. Tommaso (I. II. 107), nel quale sono anche citati i passi di Ezechiele
e Gregorio presenti nel primo pannello. L’Aquinate è dunque
il teologo della “Legge dell’Amore” del Nuovo Testamento
contrapposta alla “Lex Timoris” del Vecchio, l’auctoritas alla
base tanto del manoscritto veneziano quanto del dipinto dell’Angelico.
La successione delle scene e la scelta dei testi di accompagnamento appare
identica, con qualche eccezione, nell’Armadio e nel manoscritto.
Quest’ultimo, sulla base dello stile dei disegni acquerellati, sembra
risalire ai primi del Quattrocento ed essere di fattura norditaliana, forse
veneta. Secondo Gilbert il ponte con il domenicano Angelico potrebbe individuarsi
nell’ambiente dell’Osservanza servita: molti serviti osservanti
provenienti dal Veneto sono attestati presso la SS. Annunziata a partire dal
1441, per iniziativa del veneziano Eugenio IV, favorevole agli osservanti;
il più importante convento osservante era quello di S. Alessandro a
Brescia, che aveva commissionato proprio all’Angelico nel 1431 una tavola
con l’Annunciazione, pagandola nove ducati. Gilbert ritiene
l’entità del compenso consona ad un dipinto di piccole dimensioni,
non ad un pala d’altare, come si crede in prevalenza negli studi angelichiani,
che sarebbe andata perduta, cadendo così l’ipotesi, finora assai
accreditata, che essa possa essere stata eseguita e non consegnata (molti l’hanno
identificata infatti con l’Annunciazione di Montecarlo) e che
la pala commissionata a Jacopo Bellini nel 1444 possa considerarsi sostitutiva
del dipinto dell’Angelico.
Nel manoscritto ciascun episodio neotestamentario è accompagnato
da due precedenti tipologici veterotestamentari, di cui uno illustrato:
l’Angelico mantiene solo il testo del typus non illustrato.
La penultima scena dell’Armadio, sempre interpretata
come Incoronazione della Vergine in virtù dello schema
iconografico (malgrado l’implausibile seriorità rispetto
al Giudizio e la non pertinenza delle iscrizioni), grazie al confronto
con il manoscritto trova il suo reale soggetto nel Riposo eterno
dell’anima ovvero Cristo incorona la vita eterna,
presente anche nella Biblia Pauperum e la cui fonte prima è un
passo della Civitas Dei di Agostino.
Le tre scene su citate dipinte dal Baldovinetti hanno sempre costituito
un problema, sia quanto alla datazione, sia quanto all’ordine
invertito tra le Nozze di Cana e il Battesimo, sia perché si è spesso
creduto che in origine gli episodi della vita adulta di Cristo fossero
di più, nove e non solo tre, così come nove sono le storie
dell’infanzia. Una conferma in tal senso parrebbe venire del
manoscritto marciano, in cui appunto sono nove, per un totale di quarantuno.
Gilbert tuttavia, confrontando le dimensioni della cappella con quelle
dell’Armadio nel suo insieme, argomenta che non ci sarebbe
stato spazio sufficiente per le ipotetiche sei scene supplementari:
di conseguenza sarebbe stata operata una selezione tra gli episodi
della vita adulta, scartando i soggetti meno noti e meno (o quasi mai)
ricorrenti nella tradizione, e dando un risalto particolare al Battesimo,
in quanto sacramento; altrettanto si verifica con l’Eucarestia,
simboleggiata da più episodi, e l’enfasi sacramentale è ribadita
dall’elencazione di tutti i sacramenti – con i rispettivi
passi biblici di riferimento – nel pannello conclusivo della Lex
Amoris. In questo l’Angelico concentra, con miniaturistico
virtuosismo, un sistema di iscrizioni che nel manoscritto occupa due
pagine supplementari. Alla serie dei sacramenti in basso corrisponde,
nella metà superiore, la serie dei dodici articoli del Credo
niceno, con i ‘tipi’ relativi: qui il pittore mostra di
attingere anche a codici del genere “Speculum Theologiae” (come
il Salterio di Robert de Lisle).
Fin qui i meriti, come si vede molti e considerevoli, dello studio
di Gilbert; non si può però tacere qualche appunto. Innanzitutto
viene ignorata la voce bibliografica più puntuale ed esaustiva
relativa all’Armadio, la scheda di Andrea De Marchi
nel catalogo della mostra Una scuola per Piero (Venezia, 1992,
pp. 114-120), i cui risultati nella ricostruzione della configurazione
originaria dell’Armadio e della sua vicenda storico-critica
anticipano molte delle conclusioni dello studioso americano. A proposito
dell’intervento del Baldovinetti si può osservare che
mentre De Marchi, come già molti altri, lo datava in contemporanea
o a ridosso dell’esecuzione angelichiana (l’opera nel suo
complesso potrebbe essere stata pronta per la data di consacrazione
della cappella, l’8 gennaio 1453, e sicuramente entro il 22 dicembre
dello stesso anno, quando alcuni operai sono pagati per il montaggio
degli stipiti), Gilbert lo sposta invece un decennio più tardi,
al momento della trasformazione del sistema di apertura; a me sembra
preferibile la prima ipotesi (va ricordato che il Baldovinetti risulta
documentato in relazione alla chiesa fin dal 1450, poi ancora nel 1454
e nel 1460-63), giudicando verisimile una chiamata dell’artista
più giovane a completamento dell’opera, rimasta interrotta
per la chiamata dell’Angelico a Roma dopo il biennio in cui fu
priore del convento domenicano di Fiesole (1450-52), e anche in considerazione
del carattere schiettamente angelichiano, tale da far sospettare l’esistenza
almeno di un disegno preparatorio di mano dell’Angelico, delle
composizioni baldovinettiane, pur stilisticamente improntate a una
diversa epidermicità materica sensibile alla lezione di Domenico
Veneziano.
In merito poi alla funzione del dipinto dell’Angelico, di sportello
di chiusura di un mobile, Gilbert ricorda come precedenti le ventotto
storie di Cristo e di san Francesco dipinte da Taddeo Gaddi nel 1335
come anta esterna di una grande credenza della sacrestia di S. Croce
(chiesa per cui l’Angelico aveva eseguito un trittico nel 1429),
oggi custodite nella Galleria dell’Accademia (già segnalate
da J. T. Spyke, Angelico, Milano, 1996, p. 80), il Reliquiario
del Corporale in smalto nel Duomo di Orvieto, la tradizione veneziana
delle porte dipinte (ad esempio delle ante di tabernacoli sugli altari),
nonché, su scala monumentale, le porte bronzee del Ghiberti
per il Battistero di Firenze; a questi ritengo che si debbano aggiungere
anche alcuni esempi senesi, in particolare l’Arliquiera del
Vecchietta per la ex cappella delle reliquie in S. Maria della Scala
(1444), preceduta nel secondo Trecento dal trittico a sportelli del
Museo di Pienza (proveniente dalla chiesa di S. Niccolò a Spedaletto)
e nel primo Quattrocento dall’armadio di Benedetto di Bindo per
la sacrestia del Duomo di Siena, e seguita dalle Storie di S. Giovanni
Battista di Giovanni di Paolo (cfr. C. B. Strehlke in La pittura
senese del Rinascimento, Milano 1989, p. 231).
Infine, Gilbert definisce l’Armadio degli Argenti “l’ultima
opera dipinta da Fra Angelico, prima della sua morte nel 1455”.
Tuttavia, come credo di avere dimostrato in altra sede (“Ricerche
di storia dell’arte”, 76, 2002, pp. 41-87), l’Angelico
si recò a Roma negli ultimi anni di vita (forse già dopo
aver rifiutato, nel marzo del 1452, l’offerta di decorare la
cappella maggiore del Duomo di Prato) per affrescare il chiostro di
S. Maria sopra Minerva con il ciclo delle Meditationes elaborato
dal cardinale spagnolo Juan de Torquemada, committente dell’opera.
Tale ciclo, includente storie del Vecchio e del Nuovo Testamento ed
altri soggetti (come lo stesso cardinale in adorazione di san Sisto,
la processione del Corpus Domini, la Messa dei morti), era contraddistinto
da una cospicua presenza di testo scritto in calce ad ogni scena. L’interrelazione
quanto mai complessa e inestricabile di parole ed immagini era ancora
più sviluppata di quanto avviene nell’Armadio degli
Argenti, che pure viene a ragione indicato da Gilbert come l’opera
in cui l’impiego di iscrizioni da parte dell’Angelico (artista
tra i più inclini all’adozione di inserti verbali lungo
tutto il corso della sua produzione) raggiunge il suo acme. Inoltre
il ciclo perduto è ricostruibile dalle illustrazioni di alcuni
codici manoscritti e incunaboli a stampa delle Meditationes,
che riproducono in modo spesso molto fedele le composizioni originarie:
si profila così, sia pure con un rapporto inverso rispetto a
quello tra il manoscritto marciano e la Lex Amoris, un quadro,
meritevole di approfondimenti ulteriori, degli ultimi anni dell’attività del
pittore domenicano contrassegnato da un intreccio sempre più fitto
tra produzione pittorica e cultura letterario-teologica, con un fertilissimo,
reciproco interscambio tra progettazione iconografica e sistema di
elaborazione e impaginazione dei libri illustrati.
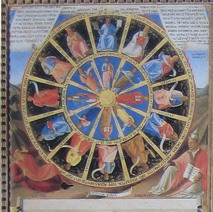
Beato Angelico, Rota in medio rotae, part.
dell’Armadio
degli Argenti, Firenze, Museo di San Marco

Beato Angelico, Cristo incorona la vita eterna, part. dell’Armadio
degli Argenti, Firenze, Museo di San Marco

Rota in medio rotae, Venezia, Bibl. Marciana, ms. Lat. I, 72
[=2501], f. 1v
Simone Ferrari, Jacopo de’ Barbari. Un protagonista
del Rinascimento tra Venezia e Dürer, Milano,
Bruno Mondadori (collana “Sintesi illustrata”), 2006,
256 pp., ill. in b/n e a colori, ISBN: 88-424-9238-8, € 40,00.
di Federica Veratelli
Il volume di Simone Ferrari colma una lacuna spesso lamentata nel
panorama degli studi sull’ambiente artistico veneziano fra Quattro
e Cinquecento e i suoi legami con il Nord. La definizione della personalità artistica
di Jacopo de’ Barbari è questione spinosa, perché viziata
da una vicenda storiografica ampia e stratificata, che ha dato luogo
a malintesi interpretativi e ad uno scenario «quasi privo di
certezze», come indica lo stesso studioso nella premessa al volume
(Questioni risolte e problemi aperti, p. VII). Nella bibliografia
sull’artista «luogo e data di nascita, formazione, interpretazione
del simbolo del caduceo, catalogo dei dipinti, cronologia delle incisioni,
rapporti con Dürer, valore intrinseco dell’artista vengono
infatti prospettati secondo opposte modalità o non trovano soluzione».
La ricerca – che trova pubblicazione in questa che si presenta
come la prima monografia sull’artista – ha creato sin da
subito non pochi problemi, in parte superati grazie alla verifica dei
documenti e ad un attento spoglio bibliografico, che ha permesso di
rintracciare testimonianze successive poco conosciute sull’artista,
contribuendo a fornire un quadro più completo su questa personalità eclettica
del Rinascimento veneziano. Infatti, è soprattutto attraverso
la sua fortuna critica (cui questo lavoro dedica ampio spazio) che
la figura di Iacomo de Barberino Veneziano (come lo chiama
il Michiel) sembra acquistare rinnovato vigore e fuoriuscire dal panorama «assai
nebuloso» che lo ha sempre contraddistinto: fortuna critica che
qui è «intesa non come successione di diverse opinioni
ma come fondante momento di snodo, di possibile soluzione di singoli
problemi, di variegato telaio che contribuisce a delineare l’effettiva
e non banale caratura del maestro».
Proprio ad un primo dispiegamento di alcune questioni legate alla analisi
della sua fortuna critica è dedicato il primo capitolo (La
fortuna critica di Jacopo de’ Barbari: problemi di geografia
artistica, pp. 1-15), che indaga con chiarezza e cognizione le
prime indicazioni e le letture che si sono susseguite dal Cinquecento
in poi, con momenti di alta concentrazione critica successiva, come
l’Ottocento e il Novecento. Le tematiche , alla «sfortuna» critica
che invece sembra investirlo in patria sin dal silenzio vasariano,
dal rapporto con l’incisione italiana (Mantegna) e nordica (Schongauer
e Dürer), al nesso «labile e poco risolutivo» Barbari-Bellini,
fino ai richiami alla bottega di Alvise Vivarini, al Messina e al Lotto.
Partendo dai dati più sicuri come la sua origine veneziana (già attestata
da Michiel come da Dürer), lo studioso propone, inoltre, soluzioni
ad alcune controversie attraverso una rigorosa verifica e contestualizzazione
dei dati a nostra disposizione: come la data di nascita, per la quale
viene suggerito il 1475, una data che sembra concordare con la cronologia
individuata delle opere. Altre questioni di difficile soluzione riguardano,
in primo luogo, «l’impossibilità di circoscrivere
il suo stile entro i tranquillizzanti parametri di una “scuola
regionale” e di ricondurre le opere fra comodi schemi consolidati».
Proprio questa sua caratteristica analizzata insieme alla sua «precoce
versatilità in ambito incisorio» (si veda la celebre celebre Veduta
di Venezia), riconosciuta in pieno già dal Kristeller (Das
Werk des Jacopo de’ Barbari, Berlin, 1896), induce lo studioso
a riflettere maggiormente sulle origini del maestro e a ipotizzare
un legame di parentela stretto con Georg Walch, celebre stampatore
tedesco attivo a Venezia fra gli anni settanta e ottanta del Quattrocento
(cap. 2: Una traccia per le origini di Jacopo de’ Barbari,
pp. 17-22). Il terzo capitolo (Gli anni veneziani di Jacopo de’ Barbari,
pp. 23-49, già apparso nel 2002 in forma di articolo in «Arte
Veneta», 59, pp. 66-83) è dedicato, invece, alla questione
del “caduceo”, ovvero l’emblema utilizzato dall’artista
per siglare le opere (soprattutto le incisioni), alla formazione in
ambito veneziano e alla prima attività pittorica e incisoria.
Altre problematiche sorgono in relazione alla «disgiunzione» esistente «fra
l’attività grafica e quella pittorica che si manifesta
a vari livelli e riaffora in diversi momenti». Una discontinuità che
si riflette anche nella scelta delle fonti figurative, che induce lo
studioso a riconoscere due fasi distinte nell’attività pittorica
del maestro: una prima “italiana” e una seconda (a partire
dal 1500) più marcatamente “nordica”. È a
quest’ultima fase che è dedicato essenzialmente il quarto
capitolo che si occupa del percorso figurativo dopo gli anni veneziani
e che tenta di ricostruire il catalogo pittorico ed incisorio fortemente
influenzato da modelli stilistici e tematici nordici (Dopo Venezia:
il percorso figurativo, pp. 51-59). A favore della ricostruzione
di questa fase (a partire dal 1500 in poi), concorrono un «decisivo
incremento dei dati a nostra disposizione»: dati generati dai
suoi spostamenti e provenienti dai luoghi di soggiorno (come Norimberga,
Wittemberg, Malines, Bruxelles e Anversa), come dai nomi dei committenti
certificati da documenti d’archivio (l’imperatore Massimiliano,
Federico il Saggio, Enrico V il Pacifico, Alberto di Brandeburgo, Filippo
di Borgogna e Margherita d’Austria). Mentre il capitolo quinto
riguarda le testimonianze di elogio da parte di umanisti e letterati
nei confronti del maestro, un aspetto dimenticato dalla storiografia
precedente sull’artista (1500-1508: Jacopo de’ Barbari
fra gli umanisti, pp. 61-68), il sesto e ultimo capitolo si occupa
della fortuna letteraria di Jacopo de’ Barbari nel decadentismo, “un
filone” come osserva Ferrari «fino ad ora trascurato ma
non privo di allusioni, menzioni, spunti critici (alternati a fraintendimenti)
relativi all’artista» (La fortuna di Jacopo de’ Barbari
nel decadentismo, pp. 69-78).
Segue l’accurato catalogo delle opere che costituisce un punto
di riferimento essenziale per gli studiosi, dove trovano una convincente
collocazione i dipinti (come il problematico Commiato di Cristo
dalla Madre della Galleria Franchetti, il discusso Ritratto
d’uomo con la Coppia di nudi di Berlino, la celebre Natura
morta di Monaco, datata e firmata), le incisioni su rame, le xilografie,
i disegni, le opere già attribuite. Concludono gli apparati:
un regesto, una utilissima appendice documentaria che raccoglie le
trascrizioni di tutti i documenti relativi al maestro e l’aggiornato
(e impressionante) corpus bibliografico di riferimento.

Jacopo de’ Barbari, Commiato di Cristo dalla Madre,
olio su tavola, 1498-1499 circa, Venezia, Galleria Franchetti alla
Ca’ d’Oro.

Jacopo de’ Barbari, Veduta di Venezia, xilografia
(stampata su sei fogli), 1500, Venezia, Museo Correr.
Donne d’arte.
Storie e generazioni, a cura
di Maria Antonietta Trasforini, Meltemi Editore, 2006, ill. b/n, pp.
236, € 19,50.
di Cecilia Vicentini
Fin dai primi anni Settanta in America e in Europa prende avvio la
ricerca sul tema delle donne artiste, promossa e condotta da studiose
di vari settori disciplinari e, naturalmente, storiche dell’arte.
E’ con Linda Nochlin, agli albori del 1973, con i suoi allarmati
interrogativi sull’assenza delle donne nei racconti di storia
dell’arte, che prese avvio una prima fase di studi tesa a riconferire
la legittima rilevanza a figure femminili del passato da sempre ignorate;
qualche anno dopo (1979) fece eco dall’Inghilterra la voce di
Germaine Greer mentre negli anni Ottanta (1981) con Roziska Parker
e Griselda Pollock la questione delle costruzioni di genere - ossia
l’insieme delle strutture culturali del maschile e del femminile
nella società - appariva già nella sua complessa natura
di fenomeno proteiforme.
Su questo terreno scosceso per molti versi e ancora privo di un saldo
sostrato teorico, si innesta il libro curato da Maria Antonietta Trasforini
che prende vita da una serie di conferenze sulla presenza delle donne
nell’arte, dal titolo Donne arte: visibilità e memoria,
promossa dall’Udi (Unione Donne Italiane) e dalla Casa delle
Donne di Pesaro, svoltesi nell’arco del 2004. Un taglio sociologico
accomuna i vari interventi che, benché scaturiti da esperienze,
generazioni, siti ed attività diverse, lasciano trapelare,
in quanto riflessioni sul tema, l’intenzione della curatrice
di rendere il ruolo delle donne nell’arte un oggetto di studio
sistematico anche in Italia ma altresì di adottarne il punto
di vista di genere per riscrivere una storia socio-culturale finora
parziale e “a senso unico”. Un primo passo in tale direzione
era già stato mosso da Maria Antonietta Trasforini qualche anno
fa con la pubblicazione del volume Arte a Parte. Donne artiste
fra margini e centro (Milano, FrancoAngeli, 2000) e con l’attività di
curatela nell’ambito dell’ormai XII edizione della ferrarese
Biennale Donna, organizzata dall’Udi di Ferrara in collaborazione
con la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della stessa città.
Funzionalmente diviso in due parti, il volume è attraversato
da un gran numero di protagoniste e co-protagoniste, mai solo semplici
comparse, che, da altrettanti ambiti di provenienza, rivestono gli
alterni ruoli di storiche-contemporanee-narranti, artiste, imprenditrici,
mogli e figlie-narrate, intessendo una fitta trama di corrispondenze
fra interpreti. La prima sezione, indicativamente chiamata Storia/Storie
dell’arte, volge lo sguardo al passato nel tentativo di
rimarcare, sfruttando una nuova e consapevole cognizione di sé,
l’impellente necessità di ridare voce e visibilità a
chi, fino a tempi recenti, è rimasta “a parte”.
Alle artiste futuriste è dedicato l’intervento di Lia
Giachero utile a dimostrare quanto le strutture mentali dei primi decenni
del Novecento ancora non fornissero a queste donne, capaci di creare
e di scendere in campo nello schieramento di uno storico movimento
d’avanguardia, gli strumenti utili ad identificarsi in un concetto
di genere, plasmate dal complesso e apparentemente ambiguo ruolo di
cui il movimento marinettiano rivestì le proprie donne. Alla
luce della vasta risonanza culturale ed artistica riconosciuta oggi
alla loro cospicua presenza in queste fila, a partire dalla pubblicazione
del 1982 di Claudia Salaris (Le futuriste. Donne e letteratura
d’avanguardia in Italia (1909-1944)) fino al fondamentale
contributo di Mirella Bentivoglio e Franca Zoccoli del 1997 (The
Women Artists of Italian Futurism. Almost lost to History), risultano
di particolare interesse i saggi di Sabrina Spinazzè, Elena
Pontiggia ed Anty Pansera, illuminanti per comprendere come le donne
abbiano saputo affrontare e valorizzare lo “spazio” in
cui coercitivamente vennero ghettizzate fino agli anni Cinquanta. E’ proprio
il concetto di spazio ad essere indicato dalla curatrice stessa nell’Introduzione come
tema chiave nell’analisi dei diversi contributi, una sorta di
filo rosso che, assumendo via via accezioni diverse, propone un sempre
valido punto di riferimento interpretativo. Spazio “pubblico” come
raggiungimento di un percorso che muove dagli spazi privati riservati
alle donne di fine Ottocento, quando Berthe Morisot e Mary Cassatt
erano indotte a dipingere per lo più ambienti loro accessibili
connotandoli sulla tela di misogine demarcazioni; o “spazio della
tutela” dell’Associativismo femminile durante il Ventennio,
quando le potenziali eversive del gruppo femminista vennero forzatamente
convogliate negli argini della politica fascista; o ancora passaggio
da uno spazio domestico ad un ambiente imprenditoriale come Anty Pansera
delinea sottolineando le capacità delle artiste/artigiane di
primo Novecento.
Sabrina Spinazzè si inserisce in questo quadro ripercorrendo
i momenti principali della valorizzazione dell’attività intellettuale
e artistica femminile nel periodo fascista: ne individua gli organi
costitutivi, i piani di azione e le fondamentali figure di riferimento
attive nell’illusoria partecipazione ad una vita pubblica ad
appannaggio, allora, esclusivamente maschile. E’ lo spazio di
un singolare compromesso quello in cui indaga la Spinazzè, il
campo d’azione che donne come Maria Castellani, Antonietta Paoli
Pogliani e Adriana Apolloni hanno ritagliato, sotto il vessillo dell’ A.N.F.D.A.L.,
fra una ferma volontà di partecipazione al lavoro e alla cultura
e l’immolarsi all’imprescindibile funzione riproduttiva
nel nucleo famigliare. Se per la lettura di questi contributi non si è reso
finora urgente il ricorso a specifiche opere, con l’intervento
di Elena Pontiggia lo sguardo sull’arte si fa più preciso
e mirato a singole personalità tutte riconducibili a determinati
movimenti o tendenze ascrivibili agli anni fra le due guerre, mai soggetti
artisticamente isolati. Nello studio di artiste come Edita Broglio,
Paola Consolo, Antonietta Raphael, Carla Badiali, Maddalena Nodari
e Genni Mucchi - alcune delle quali presenti nella recente retrospettiva
tenutasi a Roma presso la Galleria Cortese & Lisanti dal titolo Donne
d’arte. Pittura a Roma da Antonietta Raphaël Mafai a Giosetta
Fioroni - si richiede l’utilizzo da parte del lettore di
quegli stessi strumenti d’analisi contestuali e sociologici atti
ad indagare il contesto d’azione secondo direttive di genere.
La seconda parte del testo, intitolata Arte relazionale e narrazione,
si fa dinamica e decostruttiva. Dopo uno sguardo rivolto al passato
e finalizzato ad un faticoso recupero del dimenticato, ora si parte
da un’affermazione femminile in campo artistico ormai assodata
ed universalmente riconosciuta, documentata dalla metà degli
anni Ottanta, ad esempio, dalla rivista tedesca «Kapital» nell’annovero
di un numero sempre più consistente di donne all’interno
della propria Kunstkompass annuale. Gli interventi delle autrici che
ritroviamo in questa seconda sezione, Laura Iamurri, Emanuela De Cecco,
Giorgina Bertolino ed Annalisa Cattani, non si soffermano però su
questo dato comprovato e statico ma stimolano l’attenzione del
lettore nei meandri di un percorso finalizzato a sviscerarne i molteplici
fattori costitutivi all’insegna del concetto di “relazione”.
Naturalmente non vengono presentati con una pretesa esaustiva
ma si propongono come brevi compendi dotati di una professionale impostazione
teorica concepita come fonte di inevitabili riflessioni critiche.
Il contributo forse più emblematico ai fini della comprensione
di un tale pensiero è il testo di chiusura di Emanuela De Cecco
per la volontà di rendere palpabile ciò che il contesto,
inteso come insieme delle “ragioni complesse che stanno attorno
all’arte come pratica….” può determinare.
L’autrice estrapola dal proprio libro di conversazioni con diciannove
artiste, chiamate ad esporre alla mostra Non toccare la donna bianca tenutasi
presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino dal settembre
2004 al gennaio 2005, alcune parti significative. Sono narrazioni che
si svolgono “a margine di una mostra” ma che ne risultano
parte integrante e fondamentale in quanto riflessioni non sull’oggetto
artistico quanto piuttosto sul fare arte. Le protagoniste provengono
per lo più da paesi in cui la situazione socio-politica risulta
difficile, Bosnia, Sudafrica, Brasile e Russia, ed imprime tracce ben
riconoscibili nello svolgimento di una pratica che risulta particolarmente
intaccata in condizioni di negatività. Il contesto, termine
da considerare veramente nella sua accezione più ampia, dall’ambito
famigliare a quello geo-politico, le scuote ispirandole oppure le paralizza
e disorienta, le spinge ad andarsene e a tornare, ma sempre emerge
come variabile attiva influendo anche sulla ricerca di una propria
identità in termini di appartenenza o estraneità rispetto
ad un movimento, un linguaggio artistico, una famiglia. Testimonianze
dunque che mostrano il delinearsi di questa in relazione a variabili
molteplici ed ineludibili che fanno della donna un soggetto storico
cui riferirsi per misurare le distanze fra le diverse società.
Distanze e difformità che la De Cecco, in veste di critica e
curatrice, sa di dover trasporre e trasmettere in assetti fruibili
dove trovino adeguati spazi per esprimersi e mettersi a confronto.
Tutti i messaggi di questa seconda sezione del volume emergono altresì da
una contrapposizione, da un incontro, da un accostamento di entità di
cui necessariamente si frantumano i confini per poi riabbozzarli secondo
nuove conquiste fatte sul campo dell’indagine socio-artistica
e basate su una nuova autenticità dei rapporti. Le prime demarcazioni
ad essere abbattute riguardano le figure del critico d’arte e
dell’artista stesso tramite un imprescindibile richiamo ad Autoritratto di
Carla Lonzi (Bari, De Donato Editore, 1969). Laura Iamurri propone
infatti un’accurata analisi dei concetti fondamentali che informarono
questa scardinante pubblicazione artistica alla luce di alcune personali
annotazioni dell’autrice in un diario, per lo più successive
al ’69, funzionali alla ricostruzione di un pensiero e di un
contesto eversivi. La volontà di ridimensionare lo spazio e
l’autorità concessa da sempre al critico d’arte
per dare una soddisfacente risposta alla domanda che assillante si
affacciava al pensiero di Carla Lonzi - l’artista chi è?
- sposta nettamente lo sguardo, nel continuo fluire di voci degli intervistati,
dall’opera all’individuo. Non che dell’arte ci si
dimentichi ma, come in una sorta di enorme preterizione, focalizzando
l’attenzione su altro, divagando e sfuggendo, ciò che
conta emerge in tutta la sua pregnanza. Una richiesta di complicità dunque
di cui si deve registrare un fallimento alla cui permanente amarezza
si aggiunge la sconfitta nel campo del femminismo ma che porta ancora
l’autrice, nell’‘81 (testo senza titolo in Identité italienne,
L’Art en Italie depuis 1959, Paris, Centre Georges Pompidou-Firenze),
a scrivere di sé.
Lo strumento dell’intervista in campo artistico risulta protagonista
anche nello studio di Giorgina Bertolino: condotte per una collana
di cataloghi espositivi della Luigi Franco Arte Contemporanea di Torino,
le domande vengono formulate ad artisti italiani del secondo Novecento,
equamente divisi fra maschi e femmine, e riportate nel testo scritto
mantenendo la colloquialità del parlato, come Carla Lonzi già sperimentò scardinando
anche le fondamentali regole di questo genere letterario. Concepita
come mezzo di indagine comparativa l’intervista non delude mostrando
emblematiche divergenze di genere in merito a fondamentali questioni
artistiche fin dagli esordi: opera o lavoro? Una distanza semantica
che riflette dissimili approcci relazionali al mondo dell’arte
ma che svela retaggi filosofici che fanno capo ad Hanna Arendt (The
human condition, The University of Chicago; trad. it. Vita
Activa, Milano, Bompiani, 2004) e focalizza l’attenzione
su un nuovo indiscusso protagonista del modo artistico femminile di
fine Novecento: il corpo. Una fisicità in repentino mutare,
che trae linfa vitale dalle conquiste del femminismo, si fa protagonista
del quotidiano e di tante performance. Ancora demarcazioni che vengono
abbattute, ancora nuovi contorni che, più flessibili, si ridisegnano.
Non sempre fonte di serene riflessioni , infatti, ma spesso rivelatore
di ancestrali tormenti interiori, come nelle famose istallazioni di
Marina Abramovich, il corpo assume significato in rapporto ad una nuova
fondamentale variabile, lo sguardo. Sguardo di chi guarda ma anche
di chi è guardato - performance VB52 nella mostra al
Castello di Rivoli di Vanessa Beecroft, analizzata nel primo saggio
di Emanuela De Cecco - veicolo e cemento di nuove relazioni.
Naturalmente in tale contesto elemento demiurgico risulta il pubblico
e lo spazio pubblico ormai invaso e pioneristicamente occupato da donne
artiste: Annalisa Cattani esplora, artista lei stessa, alcuni esempi
di Public Art nei lavori di Elisa Vladilo, Eva Marisaldi, Mili Romano,
Sabrina Muzzi e Adriana Torregrossa, per dare prova del nuovo assetto
dell’arte contemporanea cui non è più consono allineare
l’aggettivo “femminile” in quanto specificazione superflua
nella comprensione dell’opera. I lavori di queste artiste italiane
vengono presentati per essere letti nella loro carica concettuale, nel
loro apporto alla ricerca artistica degli ultimi anni, nella capacità di
utilizzare tutti gli strumenti oggi possibili per l’espressione
di concetti universali.

Vanessa Beecroft, VB 52, performance, 2003, Castello di Rivoli
Scarica in versione pdf  |